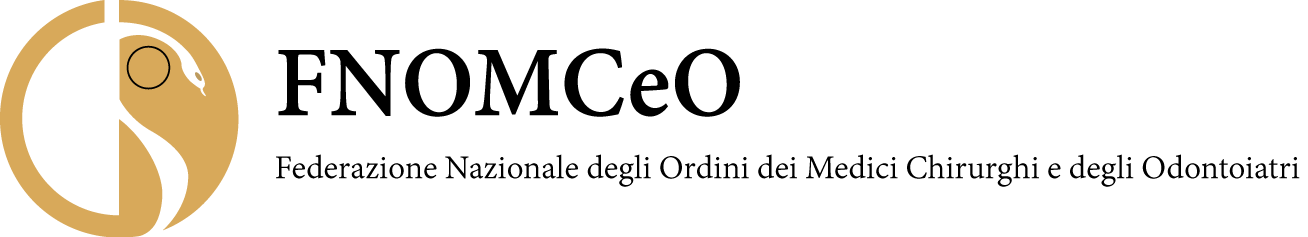Report n. 20/2011
IN ITALIA LAVORA SOLO IL 46,4% DELLE DONNE Fino alla metà degli anni ’70 gli economlsti pensavano che la disoccupazione potesse essere un fenomeno destinato a scomparire nei Paesi industrializzati. In realtà, i dati registrati negli ultimi due anni, fino al primo trimestre del 2010, ci rivelano un aumento del tasso di disoccupazione di poco più del 50%, con 17 milioni di nuovi disoccupati nei Paesi dell’area OCSE, nonostante l’economia mondiale stia uscendo dalla peggiore crisi finanziaria ed economica degli ultimi cinquant’ anni. Se si aggiungono i lavoratori sottoccupati e quelli non molto attivi nella ricerca di lavoro, il risultato diventa circa due volte superiore al tasso ufficiale.
Fino alla metà degli anni ’70 gli economlsti pensavano che la disoccupazione potesse essere un fenomeno destinato a scomparire nei Paesi industrializzati. In realtà, i dati registrati negli ultimi due anni, fino al primo trimestre del 2010, ci rivelano un aumento del tasso di disoccupazione di poco più del 50%, con 17 milioni di nuovi disoccupati nei Paesi dell’area OCSE, nonostante l’economia mondiale stia uscendo dalla peggiore crisi finanziaria ed economica degli ultimi cinquant’ anni. Se si aggiungono i lavoratori sottoccupati e quelli non molto attivi nella ricerca di lavoro, il risultato diventa circa due volte superiore al tasso ufficiale.
In Italia, secondo i recenti dati Istat, ad avere un’occupazione lavorativa è il 57,5% della popolazione tra i 15 e i 64 anni. Ad essere penalizzate sono maggiormente Ie donne che, a fronte del 68,6% degli uomini occupati, rappresentano il 46,4%, portando l’Italia al di sotto della media europea (pari al 58,3%), lontano dalle indicazioni della strategia di Lisbona in base alla quale i Paesi membri, entro il 2010, avrebbero dovuto dare occupazione al 60% delle donne tra i 15 e i 64 anni.
La probabilità di uscire dal mercato del lavoro (49% in media) aumenta significativamente per Ie madri sotto i 24 anni (72%) e per quelle meno istruite (68%) che si sono fermate alla licenza media (contro il 24,5% delle laureate), addirittura triplica per Ie mamme che al momento del concepimento lavoravano a tempo determinato. La nascita di un figlio per numerose donne rappresenta dunque la principale causa di abbandono temporaneo o definitivo del mercato del lavoro. E sono sempre Ie donne che nell’80% dei casi sono costrette a scegliere il part-time, o a rinunciare alle prospettive di carriera e di maggiore retribuzione.
Così che una buona percentuale di donne, il 17,2%, preferisce rinunciare ad avere figli per paura di perdere la propria occupazione; soprattutto le giovani tra i 18 e i 24 anni evitano scelte dl vita impegnative, come la maternità, per paura di perdere il posto di lavoro nel 31,1% dei casi o di incorrere in difficoltà economiche nel 29,5%.
Ancora una volta il tessuto sociale e culturale ostacola la conciliazione tra vita privata e professionale ed è frequente che le donne. siano costrette a "risolvere il problema" da sole, rinunciando al lavoro o al figlio piuttosto che ricorrere al decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 a tutela della maternità, più volte tranquillamente eluso dal datore di lavoro attraverso strategie vincolanti. Così che nelle fasi centrali della vita delle donne, in cui è maggiormente sentita la necessità di intrecciare vita personale e professionale, l’appartenenza al "genere" rappresenta una discriminante sia per l’accesso sia per la permanenza nel mercato del lavoro. Al lavoro femminile non viene riconosciuta piena legittimità sociale malgrado l’esistenza di misure legislative di attenzione e tutela per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni delle donne sul lavoro. Pensiamo al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 attuativo della direttiva CE/5412006 e in vigore dal 20 febbraio 2010 che sancisce "l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”.
Altro dato su cui occorre riflettere riguarda l’inattività delle donne riscontrata nel 48,9% dei casi; all’incirca 10 milioni di donne, anche molto giovani, non studiano e non cercano lavoro. La situazione, in aumento dal 2004, è presente soprattutto al Sud. L’inattività non sempre è dovuta ad una decisione personale, come ci indica l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori che ha indagato rispetto alle motivazioni di questa eventuale scelta/non scelta.
Secondo i risultati dell’indagine, i fattori determinanti sono la famiglia (il ruolo e il carico di lavoro legato alla cura dei figli o dei parenti non autosufficienti), il modello di welfare (carenza di servizi per l’infanzia o di reti familiari e informali) e l’organizzazione del lavoro (bassi livelli di conciliazione tra lavoro e famiglia, rigidità degli orari di lavoro).
Come indica l’Eurispes (2008), l’impedimento ad entrare nel mercato del lavoro spesso deriva dalla famiglia: nel 7,6% le donne sono costrette ad abbandonare il lavoro per le "esigenze familiari" che sopraggiungono dopo il matrimonio, nel 5,1% sono esplicitamente ostacolate a lavorare o dal marito o dalla famiglia d’origine e quindi condannate all’esclusione sociale e politica.
Una donna privata della capacità e dignità produttiva, ha difficoltà ad affermarsi, non essere "portatrice di i reddito" le impedisce di essere titolare di diritti. Una condizione che tra l’ altro rafforza il ruolo assegnato per tradizione alla donna e che forse potrebbe spiegare i comportamenti rinunciatari di alcune di esse. Sta di fatto che la funzione economica di produttrice o consumatrice influenza la condizione sociale della donna. Nella storia degli Stati Uniti ad esempio le donne che per tutto il diciassettesimo e diciottesimo secolo avevano contribuito in modo diretto alla vita economica del loro Paese, con l’avvento della industrializzazione, sono passate da una condizione di produttività e di visibilità sociale all’accudimento della casa e della famiglia, divenuta il loro rifugio.
Roma 02/05/2011
Autore: Redazione FNOMCeO