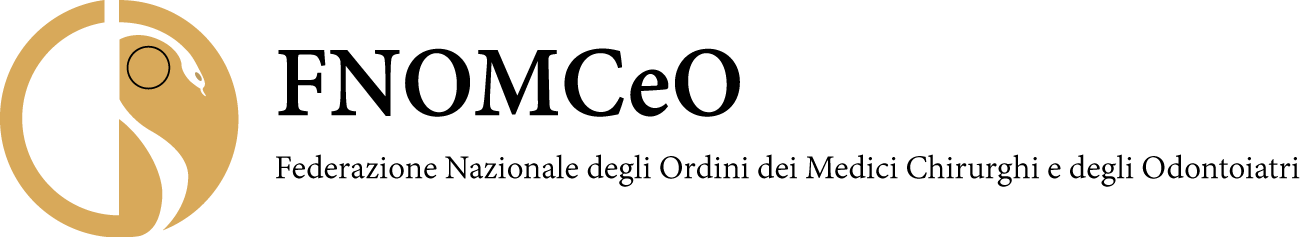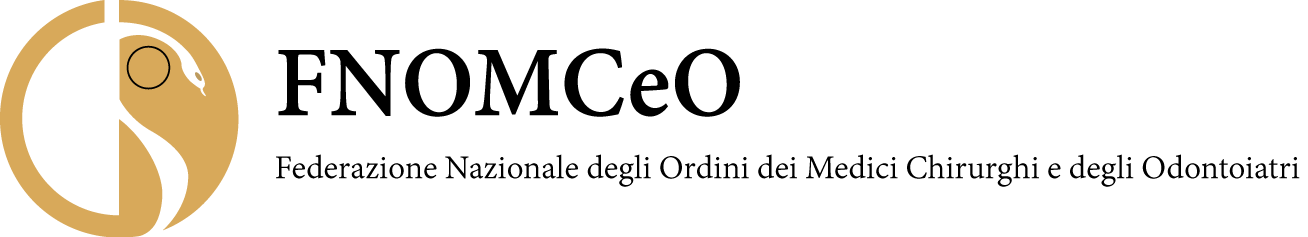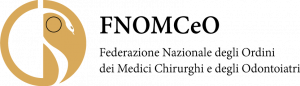L ’importanza dell’integrazione tra medicina e discipline umanistiche.
Danielle Ofri vive e lavora a New York, è medico di medicina interna, PhD e professore associato presso la New York University School of Medicine. Lavora da oltre vent’anni presso il Bellevue Hospital, il più antico ospe- dale pubblico degli Stati Uniti, ed è nota per i numerosi libri: racconti in prima persona della propria esperienza di medico ospedaliero, scritti con uno stile scorrevole, con la chiara intenzione di rivolgersi non solo ai colleghi quanto ai pazienti, e in generale a un pubblico non spe- cialistico, come attestano anche i numerosi articoli per testate come «New York Times» e «Washington Post» oltre agli interventi per il TED Talks. È co-fondatrice e capo-redattrice della «Bellevue Lite- rary Review», rivista letteraria concepita e pubblicata all’interno dello stesso ospedale. Uno dei fili conduttori del suo pensiero, nonché faro di orientamento nella pratica clinica come in quella di scrittura, è il dialogo di reciproco confronto, scambio e arricchimento tra sapere scientifico e discipline umanistiche. L’ultima pubblicazione – What Patients Say, What Doc- tors Hear (2017, Beacon Press) – è tradotta in italiano da Il Pensiero Scientifico
Prima di tutto, può spiegarci che cosa significa lavorare in un ospedale pubblico a New York?
Il sistema americano può risultare molto confusivo agli occhi di un cittadino europeo (e, onestamente, lo è anche per la maggior parte degli americani!). A causa della carenza di manodopera che si verificò durante la Seconda Guerra Mondiale, per attrarre forza lavo- ro le aziende iniziarono a offrire come benefit l’assicurazione sanitaria. Questa soluzione divenne poi parte integrante del sistema, tanto che oggi la maggior parte delle persone riceve la copertura sanitaria dalle compagnie assicurative private scelte dal proprio datore di lavoro. [In questo modo] possono ricevere le cure da ogni medico e ospedale che accetti la loro assicurazione. Purtroppo, molti lavori a bassa retribuzione non offrono questo benefit, di cui non dispongono nemmeno disoccupati, anziani, disabili e fasce che rientrino nella soglia di povertà. Per queste persone, il governo americano ha istituito due programmi a finanziamento pubblico, Medicare (per la popolazione anziana) e Medicaid (per le fasce povere). Questi programmi sono un’ottima soluzione, però non prevedono un rimborso elevato (soprat- tutto Medicaid). Di fatto, però, molti medici e ospedali sono riluttanti ad accettare pazienti che dispongano soltanto di questa copertura. Gli ospedali pubblici non mancano negli Stati Uniti: sono finanziati da tasse federali e locali e accettano sia Medicare che Medicaid e anche chiunque non sia assicurato. Ma siccome gli ospedali pubblici sono finanziati anche localmente, tra stato e stato ci sono grandi dif- ferenze. Stati liberali come quello di New York e la California hanno una rete di ospedali e cliniche pubbliche molto solida. Stati più conservatori come il Texas hanno invece servizi pubblici ridotti al minimi (una situazione che a molti di noi non piace e che cerchiamo di- speratamente di cambiare). Il Bellevue Hospital, dove lavoro io, è il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti. È sta- to fondato nel 1736, e ha sempre aperto le porte a tutti. Ci prendiamo cura di chiunque, senza guardare se abbia l’assicurazione o il visto. Molti dei nostri pazienti sono immigrati senza documenti, persone senza fissa dimora, o molto povere. Qualcuno dispone di qualche forma di assicurazione, alcuni hanno Medicaid, ma molti non hanno niente. I nostri pazienti provengono da ogni parte del mondo, circostanza che fa del Bellevue un luogo di costante ispirazione per chi ci lavora. Oltre a essere un ospedale pubblico, il Bellevue è anche una clinica in cui si insegna. È affiliato alla New York University School of Medicine, che si trova a due isolati di distanza. L’Università fornisce docenti di facoltà (come me) per l’assistenza medica, e gli studenti di medicina quindi vengono qui, in questo ambiente eterogeneo e stimolante, a fare i tirocini. Ciò consente ai pazienti del Bellevue di avere accesso a tutti gli specialisti e agli esperti affiliati a una scuola di medicina tra le più rinomate del paese.
Qual è la motivazione che orienta le sue scelte professionali?
Lavoro full-time al Bellevue e sono Professore associato di Medicina alla New York Univer- sity. Coloro, tra noi, che scelgono di lavorare al Bellevue, lo fanno perché è un ambiente molto coinvolgente. Vogliamo dedicare il nostro impegno alle persone che hanno meno possibilità, e riceviamo al tempo stesso tutti gli stimoli intellettuali che derivano dall’ambito accademico, interagendo con gli studenti e partecipando all’insegnamento della medicina. In tutta onestà, non potrei immaginare un luogo di lavoro migliore. I miei pazienti sono meravigliosi, così come i miei studenti. Imparo sempre qualcosa di nuovo, incontro persone che sono costante fonte di ispirazione, e poi so che le mie energie servono per aiutare chi nella vita non ha altre risorse.
Premettendo la sua definizione di ‘medical humanities’, quanto ritiene che siano concretamente diffuse nella pratica clinica, oggi, negli Stati Uniti?
Con ‘medial humanities’ intendiamo l’intersezione tra le discipline umanistiche classiche (letteratura, filosofia, etica), le arti (belle arti, musica, teatro) e la medicina. Il sapere medico standard si può facilmente ricavare attraverso i testi medici e le lezioni tradizionali. Ma così non ci aiuta molto rispetto alla sfida che pone la condizione umana, nella sua complessi- tà. Possiamo imparare a gestire la malattia dei pazienti, ma spesso non abbiamo idea di che cosa fare quando si tratta di aiutare una persona ad affrontare la morte, l’incertezza, la paura (senza contare che, naturalmente, anche noi medici dobbiamo affrontarle!). Le ‘medical humanities’ ci aiutano quindi a esplorare questi aspetti più sottili e sfuggenti della medicina, ma altrettanto importanti.
Quando ha iniziato a scrivere e in che modo la scrittura ha cambiato la sua pratica clinica e il rapporto con i pazienti?
Già durante gli anni di tirocinio ero consapevole dell’importanza delle storie che si svolge- vano di fronte ai miei occhi, ma allora non avevo il tempo (o lo spazio emotivo) per pensarci in modo approfondito. Concluso il tirocinio ho preso un anno e mezzo di tempo per viag- giare ed è stato durante quel periodo che ho iniziato a scriverle. Non avevo intenzione di pubblicare, solo la necessità di metterle su carta a un ritmo che mi consentisse di riflettere su tutto ciò che era successo e sul modo in cui queste storie risuonavano in me e nelle persone intorno a me. Credo che sia la stessa motivazione che mi fa andare avanti oggi. Dal punto di vista pratico, dedico all’attività di scrittura l’equivalente di due giorni alla settimana (quelli in cui non sono in ospedale). Questo è il solo modo in cui riesco a trovare tempo per scrivere – compromesso che, per me, vale la riduzione di stipendio. Altri medici scrittori invece si alzano molto presto la mattina, oppure scrivono di notte, oppure tra un paziente e l’altro. Ognuno trova le proprie strategie. Gli scrittori che mi hanno ispirato includono Oliver Sacks e Abraham Verghese.
Quali testi raccoglie il «Bellevue Literary Review» e quali sono i suoi lettori? L’idea di creare una rivista più letteraria che scientifica all’interno dell’ospedale è stata immediatamente condivisa e supportata?
Il «Bellevue Literary Review» è nato nel 2001 come un forum per porre luce sulla compo- nente umanistica della medicina e in generale sull’esperienza umana. Pubblica narrativa, poesia, saggistica con il fine di esplorare le relazioni tra malattia, salute, guarigione e con l’ambizione di risultare di interesse sia a chi lavora in ambito sanitario sia a un pubblico generale. Questi temi hanno avuto delle risonanze profonde con scrittori e lettori di ogni tipo – la rivista riceve oltre 4.000 contributi all’anno e ha oltre 1.500 abbonati. I contributi che pubblichiamo arrivano da scrittori con ogni tipo di background, con storie da condivi- dere sulla fragilità e la complessità della condizione umana. Ci impegniamo a promuovere nuove voci emergenti in ogni genere e provenienti da tutte le comunità.
Secondo lei, e qui cito quasi alla lettera uno dei post del suo blog sull’argomento, ci sono delle ragioni particolarmente importanti, oggi, per continuare a ‘instillare le discipline umanistiche nella pratica medica’?
Se da una parte è frequente, tra gli studenti di medicina, il timore per la quantità di cono- scenza che devono acquisire, in realtà è la capacità di tradurre quel sapere in saggezza la più grande sfida per diventare medico. Parte di questa sfida consiste nel tollerare ambiguità e incertezze: un compito molto difficile per coloro ai quali è stato insegnato di mettere in dubbio tutto ciò che non è basato sull’evidenza o vagliato da peer-review. Le medical humanities consentono di sondare queste ambiguità e incertezze, che sono tratti carat- teristici dell’attuale pratica clinica ma raramente presi in considerazione nell’ambito della formazione medica. Richiedono inoltre capacità di riflessione e contemplazione, cruciali per prendere decisioni meditate, e anche per il benessere personale. Oltre a tutto questo, le discipline umanistiche aggiungono una dose di gioia e bellezza a un percorso di training che è notoriamente povero in questi ambiti. Ben integrate, possono essere la chiave per trasformare il sapere medico in saggezza clinica.
Intervista a Danielle Ofri – a cura di Sara Boggio (Torino Medica, Dicembre 2017 leggi qui)
Autore: Redazione