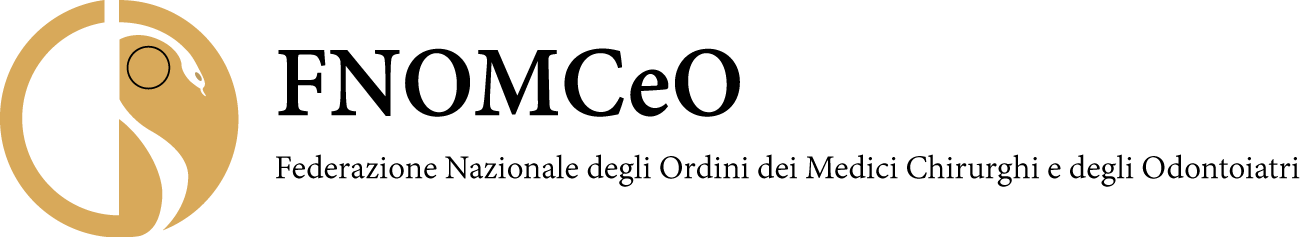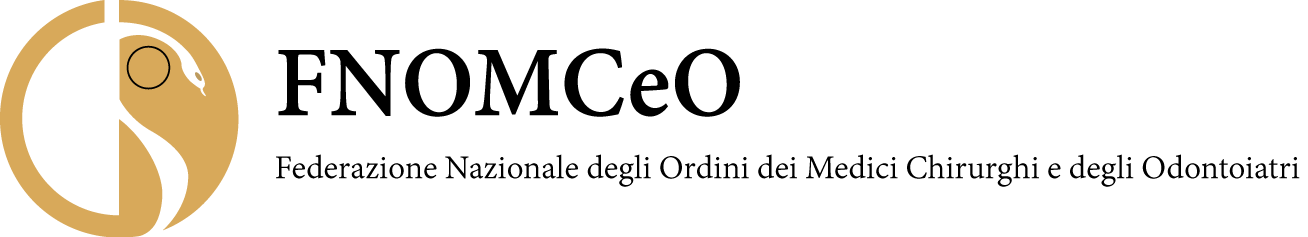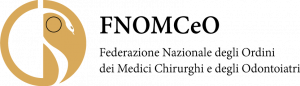In tema di esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro la Suprema Corte ne ha affermato la legittimità ove il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa.
In particolare, posto che il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza non è suscettibile di censura in sede di legittimità, mentre è consentito alla Cassazione esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato, viene rilevato che nell’ambito del rapporto di lavoro il limite di pertinenza si misura sulla rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione. Il modo in cui la critica è veicolata può certamente avere rilievo nel giudizio di pertinenza, ma questo deve muoversi non secondo il punto di vista dell’interesse pubblico o collettivo a conoscere la notizia o l’accusa, bensì seguendo il focus della inerenza di quelle modalità all’interesse meritevole di tutela e, nella specie, alle problematiche lavorative esposte.