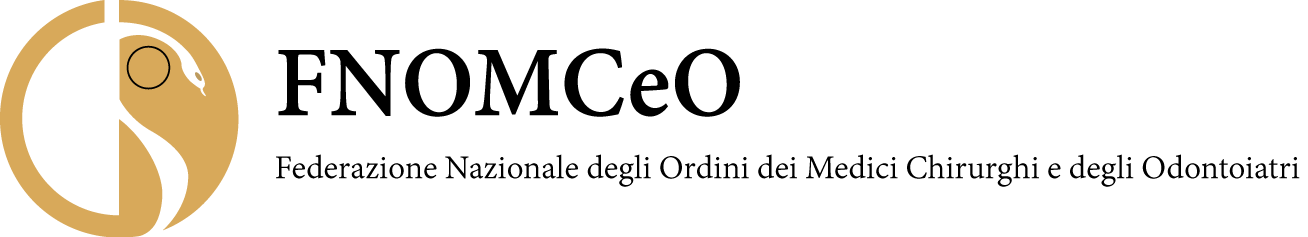Dopo l’approvazione della nuova edizione del Codice di Deontologia Medica, del Giuramento professionale e delle note applicative, numerosi commentatori hanno mosso rilievi critici sia a singoli articoli, sia all’orientamento complessivo del testo. A questi si sono aggiunti dissensi di Ordini provinciali, alcuni dei quali hanno paventato ricorsi al Tar o dichiarato tout court di non voler applicare tale Codice.
“Non mi stupisce l’eco di commenti al nuovo Codice: ne avvalorano la rilevanza civile ed etica – afferma il presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco –. E sono convinto che le critiche, quando costruttive, siano espressione di partecipazione e aiutino a crescere e a migliorare. Questo non significa condividerle ma rendersi disponibili ad una dialettica di opinioni che, in questa materia, sono molto diversificate per matrici culturali, filosofiche , sociologiche e metodologie di analisi e che scontano tra di loro elevati tassi di inconciliabilità. Gli eccessi di qualche titolo che abbiamo letto sui media e alcune forzature interpretative del testo non faranno venir meno la nostra disponibilità al confronto” .
E su tutti questi commenti, eccolo allora a rispondere, senza remore o reticenze, attraverso i canali istituzionali della FNOMCeO.
Presidente, partiamo dalle votazioni. Sull’approvazione del Codice, questa volta, non si è avuta l’unanimità: dieci Ordini hanno votato contro, due si sono astenuti e qualche commentatore sottolinea una spaccatura senza precedenti. Come interpreta questo voto?
Per una cronaca più completa e puntuale va precisato che, su un testo che aveva già recepito circa un centinaio di osservazioni, al voto finale – e dopo centotrentasette votazioni, sia articolo per articolo, sia sui singoli emendamenti – ottantacinque votanti su novantasette si sono espressi a favore.
Tra i nove assenti, molti hanno preannunciato il loro voto favorevole e, probabilmente, le astensioni e qualche iniziale dissenso si tradurranno, alla fine, in approvazioni, quando il testo, completato con il Giuramento professionale e le note applicative, sarà oggetto di più organiche e complessive valutazioni da parte dei singoli consigli direttivi provinciali, che sono stati Invitati a deliberare in merito.
Certo, alcuni dissensi rimangono, ma hanno, però, motivazioni tra loro del tutto contrapposte: alcuni dei Presidenti contrari ritengono che non occorresse procedere ad alcuna revisione, ponendo di fatto un veto “assoluto” e, sebbene più volte sollecitati ad esprimersi nel merito, non hanno cambiato le proprie posizioni.
Un’altra parte ritiene, invece, che il Codice non abbia una sufficiente forza innovativa o che sia eccessivamente piegato alle Leggi, considerazioni rispettabili ma oggettivamente poco supportate da proposte idonee a concretizzare quell’auspicato articolato “di nuovo conio”.
Ma questa mancata unanimità non costituisce un vulnus all’identità unitaria della Professione?
Il percorso compiuto ha dato opportunità di espressione a tutti e la responsabilità della mancata unanimità non può ricadere solo sulla stragrande maggioranza che ha condiviso, ma anche su quanti hanno ritenuto di compiere scelte differenti.
Il principio dell’unanimità richiede a tutti la volontà e l’umiltà di realizzare un equilibrio alto tra le proprie legittime visioni e la necessità di costruire la Deontologia come un patrimonio comune. Da questo punto di vista, confesso la mia difficoltà ad interpretare le innovazioni al codice come un vulnus etico e professionale talmente insopportabile da giustificare la rumorosa e colorita levata di scudi di alcuni dei Presidenti contrari.
La veemenza delle manifestazioni di questo dissenso ha in verità lasciato poche tracce nel merito delle questioni; molto di più ha invece consegnato ad una parata mediatica che è risultata buona a tutti gli usi e consumi, sollevando altresì il polverone di un ricorso alla magistratura civile francamente improbabile nei termini ma minaccioso (questo sì un vulnus ) per la consolidata autonomia della professione in materia.
Sottolineo invece il coro unanime di consensi della professione odontoiatrica, che, ancorché non avente formale diritto ad esprimere il proprio voto, ha partecipato con competenza e responsabilità all’ intero processo di costruzione del nuovo testo. Il che mi fa pensare che anche il dissenso sia, in qualche ordine dissidente, carente di unanimità.
Gli Ordini “all’opposizione” criticano soprattutto l’articolo 3 che, a loro giudizio, piegherebbe il medico, nelle organizzazioni sanitarie, al volere delle Regioni. Qual è, su tale punto, il suo pensiero?
È un’interpretazione capziosa o quantomeno inesatta del testo, che in realtà fa precedere all’individuazione dei doveri generali del medico quella della sue competenze tecnico professionali.
Su pressante richiesta di molti Ordini, Organizzazioni sindacali di categoria e Società scientifiche, è stato chiesto al Codice di farsi carico di definire le competenze del Medico e dell’Odontoiatra, essendo fonte di preoccupazioni la eterogeneità della matrice giuridica in materia.
Sebbene consapevoli della “natura subordinata” del Codice deontologico nella gerarchia dell’ordinamento, lo sforzo compiuto è stato quello di evitare la definizione delle competenze come una serie di atti; in buona sostanza, di prefigurare un mansionario medico. Oltre che impossibile sarebbe stata una operazione facilmente permeabile a sovrapposizioni di competenze con altre professioni sanitarie, soprattutto in contesti organizzativi che sostanzialmente mirano ad un trasferimento di atti e procedure solo in ragione dei minori costi dei fattori produttivi.
Si è perciò condivisa la scelta di individuare un testo normativo che, in modo dinamico, reclutasse alle competenze del medico tutte quelle nuove attività e quelle nuove funzioni che lo sviluppo della Medicina, della Professione e delle Organizzazioni sanitarie rende via via oggettivamente disponibili.
Attività e funzioni che costituiscono un ampliamento delle competenze di base e specialistiche, previste negli ordinamenti didattici universitari sui quali continuano a fondarsi l’abilitazione di stato, i profili specialistici e la riserva di attività professionali connesse.
Ci sono poi altri articoli che individuano i capisaldi delle competenze specifiche ed esclusive del medico e cioè la diagnosi clinica, la terapia, la prescrizione, il consenso informato.
Tornando all’articolo 3, i doveri generali del medico sono identificati nell’ultima parte. E credo che le critiche basate su un’illogica proprietà transitiva di previsioni tra le due parti di tale articolo, per cui verrebbe legittimata una subordinazione del medico alle organizzazioni sanitarie, siano quindi infondate.
Altro che vuole sottolineare?
Questa imperizia o malizia interpretativa è tanto più rilevante, quanto più incide su una questione sensibile, che costituisce peraltro l’effetto perverso di una cultura e di una pratica dominante nelle organizzazioni e nelle gestioni in sanità. Questa cultura considera infatti marginali i professionisti – e i medici in particolare – pesandoli quali meri fattori produttivi e disegnandone quindi relazioni, ruoli e funzioni, unicamente in ragione dei costi di cui sono gravati e di quelli che generano.
Quel profondo disagio professionale che da anni denunciamo, con i suoi molteplici determinanti, costituisce la manifestazione più nitida e preoccupante di una lacerazione all’interno dell’alleanza tra sistema sanitario, medici, professionisti sanitari e cittadini: quel patto fondato su valori civili, etici e tecnico professionali condivisi che ha fatto crescere, nel nostro paese, il diritto alla tutela della salute, nonostante le palesi insufficienze dei profili istituzionali (federalismo), organizzativo -gestionali (aziendalismo), finanziari (rapporto spesa sanitaria/PIL sotto il 7%) ed aree di inquinamento del malaffare, anche malavitoso, della politica. Su queste criticità, il nostro Codice fa quanto deve e quanto può; in ogni caso non è né remissivo né omissivo.
Ma l’impressione di qualche commentatore critico – dai medici cattolici Renzo Puccetti e Stefano Alice al laicissimo Ivan Cavicchi – è quella comunque di un medico troppo vincolato ai budget. Principi quale l’“uso ottimale delle risorse” e l’“appropriatezza” compaiono, in effetti, in diversi articoli. Cosa risponde?
Si tratta, in tempi segnati da sciagurati “tagli lineari”, di preoccupazioni che colgono la realtà purtroppo diffusa di una domanda di servizi a tutela della salute che cresce in qualità e quantità, a fronte di risorse che restano invece definite e comunque correlate alle disponibilità del bilancio dello stato, subendone quindi le sorti; questo è però un nodo strutturale ed ineludibile comune a tutti i sistemi sanitari fondati sull’universalismo dei destinatari, sull’equità di accesso e sulla solidarietà del finanziamento con risorse pubbliche.
Nel nostro contesto che ha le sue peculiarità soprattutto sul versante delle risorse disponibili (finanziamento pubblico al di sotto della media UE), domanda e risorse agiscono come i bracci di una tenaglia che stringono il sistema sanitario in uno spazio sempre più stretto di incompatibilità, razionando servizi, forzando le aziende sanitarie, le loro organizzazioni e gli stessi professionisti su prioritari obiettivi di tenuta contabile.
Non se ne esce, dunque?
Questo avvitamento perverso di incompatibilità non è l’unica risposta possibile alla crisi del sistema; sono possibili contesti di compatibilità tra bisogni di salute e risorse fondate non solo sul profilo economico contabile ma anche su scelte etiche, tecnico professionali e sociali che usano al meglio le risorse disponibili, invertendo il paradigma dominante in ragione del fine da perseguire e cioè la tutela della salute individuale e collettiva.
È questa la prospettiva che anima il Codice e che al medico chiede di operare non come attore anonimo ma come AutoRe, mettendo in gioco la sua Autonomia e Responsabilità; valga per tutto il richiamo, posto all’articolo 79, alle finalità delle organizzazioni sanitarie: “Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini primari della medicina”.
Più chiaro di così è davvero complicato.
Bene, come raggiungere allora tale obiettivo?
Su questo terreno scontiamo i ritardi di nuove idee o meglio di un progetto organico dopo il naufragio della Clinical Governance ma soprattutto scontiamo le eccessive frammentazioni di rappresentanze sindacali che esprimono fragilissime forme di unitarietà e faticose mediazioni di contenuti; le funzioni poco definite e autoreferenziali di società Scientifiche e – perché non dirlo – le insufficienze dei nostri Ordini professionali.
Il processo di definizione del nuovo Codice ha consegnato a tutti noi anche la ricchezza di uno schema di lavoro aperto ed inclusivo e la vocazione di realizzare, partendo dalle diversità, un disegno di bene comune per il nostro paese e per la nostra professione: dobbiamo camminare ancora su questa strada!
Alcuni Ordini contrari sostengono anche che il Codice abbia in sé una deriva che subordini le Norme deontologiche alle Leggi e ai Giudici …
Il rapporto tra l’ordinamento in senso lato ( legislazione nazionale e regionale, regolamenti, giurisdizione civile, penale ed amministrativa) derivante dalla oggettiva esigenza di tutelare gli interessi pubblici connessi alle attività mediche e sanitarie e la natura autonoma della regolamentazione deontologica produce da sempre delle “aree critiche” animate da tensioni e talora da conflitti aperti. Nel merito delle questioni poste, mi pare inconsistente l’accusa di subordinazione ai Giudici del nuovo Codice (e del Giuramento annesso), quando non persino grottesca. Si pensi solo al Caso Stamiona: nell’intricato groviglio di contraddizioni tra poteri, la FNOMCeO ha pubblicamente assunto una posizione di sostegno al rifiuto dei Medici di Brescia di proseguire i trattamenti, opposto in forza del rispetto della Deontologia, nonostante ingiunzioni giudiziarie e diffide di parte.
Ma il Caso Stamina non è l’unico complesso intreccio tra Legge e Deontologia.
Certo, proprio in questi giorni, siamo stati chiamati a rispondere all’Antitrust, una sorta di giurisdizione speciale che istruisce, giudica e sanziona presunte violazioni della concorrenza e del mercato delle previsioni del vecchio e nuovo codice in materia di pubblicità sanitaria.
All’opposto, ripetute sentenze della Corte Costituzionale – l’ultima sulla legge 40 (Procreazione medicalmente assistita) – ribadiscono che in materia di trattamenti terapeutici non è consentito al legislatore intervenire, dovendo il medico riferirsi alle più aggiornate conoscenze scientifiche ed al proprio Codice deontologico. Parimenti la Corte di Cassazione sia penale che civile ha in più occasioni affermato che il medico è tenuto a perseguire il bene della persona che a lui si rivolge e di cui porta responsabilità, non costituendo un’esimente la pedissequa osservanza di regole organizzativo gestionali o di linee guida.
Qualche giudice ha poi perseguito come abuso di ufficio l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dei CTU. Ognuno dei casi citati ha una sua complessità giuridica che attiene ad un difficile bilanciamento dei poteri e delle competenze: tutto ciò non può essere banalmente ricondotto o alle Leggi o al Codice.
Sui temi cosiddetti sensibili non mi soffermo, dando per acquisite alcune scelte confermate e rafforzate nel nuovo testo, laddove viene ribadito, in più articoli, il concetto di “Diritto mite” e cioè quell’essenziale cornice legislativa regolatoria che lasci però all’Alleanza di Cura la responsabilità, la libertà e la legittimità delle scelte.
Uno dei presunti “diritti negati” al medico sarebbe quello dell’obiezione di coscienza all’interruzione di gravidanza.
Probabilmente il riferimento è alla parte finale dell’articolo 22, laddove il medico, ancorché obiettore, resta impegnato a fornire ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.
Ci si riferisce a prestazioni esigibili, ovvero a parti costitutive di un diritto tutelato, e si sottolinea come l’informazione, quella ritenuta necessaria, possa e debba stare all’interno di una Relazione di cura, anche quando questa sia caratterizzata da un rifiuto di prestazione in ragione di coscienza o di convincimenti tecnico scientifici.
In ogni caso l’obiezione di coscienza, sotto il profilo deontologico, non è l’esercizio di una convenienza ma una testimonianza consapevole e libera di responsabilità sui propri valori etici di riferimento che sono inscindibili dall’esercizio professionale.
In campo opposto, arrivano gli appelli dei medici non obiettori, che non si sentono sufficientemente sostenuti nelle loro scelte dal Codice e dalla FNOMCeO.
Il Codice e la FNOMCeO riconoscono pari dignità etica e professionale a chi obietta e a chi non obietta, una dignità che ritengono invece offesa da tutte quelle negligenze organizzative e gestionali, da tutte quelle interferenze che surrettiziamente condizionano e talvolta coartano le scelte morali e professionali dei medici, di qualunque segno esse siano.
Queste interferenze e queste negligenze gravano pesantemente sui cittadini, in questi casi donne che compiono scelte difficili e sofferte, producendo solitudini e frustrazioni dei medici non obiettori, ma soprattutto incidendo sulla libertà di ogni professionista ad esprimere al meglio il valore etico e civile fondante della professione: stare con le persone, sempre, nel rispetto dei loro diritti e della propria coscienza e dei propri convincimenti tecnico – professionali.
Sin qui abbiamo parlato dell’autonomia del Medico. Al contrario, qualche commentatore (vedi l’editoriale del bioeticista Sandro Spinsanti, ripreso da Gilberto Corbellini ) ritiene che ci sia un revival del paternalismo medico..
Francamente non saprei dove tali preoccupazioni abbiano effettivo riscontro nello spirito e nella lettera del nuovo codice. Nel prefigurare l’ Alleanza di Cura, il riferimento alla reciprocità tra medico e persona assistita/paziente non è certo il disconoscimento di una parte (l’autonomia del paziente) ma la ricerca di quell’incontro unico e irripetibile che legittima sia le scelte tecnico – professionali, sia quelle etiche. In tal senso, il richiamo al medico di agire in “scienza e coscienza” non si traduce in una definizione unilaterale ed astratta, del miglior interesse del paziente (paternalismo ) ma nell’ operare, sul piano tecnico – scientifico, in ragione delle migliori evidenze disponibili e, su quello etico, in ragione della deontologia professionale e dei diritti della persona, in primis quello dell’autodeterminazione, a cui richiama peraltro in modo inequivocabile l’atto solenne del giuramento professionale.
Codice “paleolitico” e “gattopardesco” (SMI), “che lascia il medico nel passato” (Remuzzi), che “non è veramente nuovo” e “non pertinente con gli explananda” (Cavicchi), che “non cambia molto rispetto a quello del 2006” (Corbellini). Una critica mossa al nuovo Codice è che, in fondo, tanto nuovo non sia…
L’autorevolezza degli commentatori citati e i diversi piani di analisi sui quali hanno mosso le loro osservazioni critiche richiederebbe una risposta per ciascuno di essi. Ovviamente non è possibile farlo in questo contesto e mi scuseranno se provo a fare una sintesi di quello che credo sia il cuore del problema sollevato: se cioè il nuovo Codice assolva il dichiarato scopo di innovare ed adeguare le regole deontologiche, cogliendo a sufficienza le ansie e il disagio della Professione e soprattutto se offra risposte efficaci alle criticità che ne costituiscono i determinanti.
Non cito – perché sarebbe troppo ovvio – i quattro articoli inediti. E ho già svolto alcune controdeduzioni su aspetti specifici e innovativi: altre potrei aggiungerne, riguardo ad esempio la prescrizione terapeutica cosiddetta off label e nell’ambito dei trattamenti impropriamente definiti compassionevoli, oppure il ruolo limitato delle linee guida nella pratica professionale, la pubblicità sanitaria, la sperimentazione clinica (con un allegato inedito), le condizioni di conflitto di interessi. Infine, ma non per ultima, la scomparsa del termine accanimento terapeutico, la valorizzazione delle terapie palliative e cura del dolore, che diventano fini della medicina tanto quanto il curare per guarire. Per questo, la scomparsa del termine eutanasia (non del divieto), per affermare che la buona morte non è solo quella provocata su richiesta del paziente.
Altre specifiche e rilevanti novità/criticità della professione, quali ad esempio le difficoltà dei giovani nella formazione ed accesso al lavoro e delle donne medico a qualificare il loro straordinario ruolo civile e professionale nelle rappresentanze – compresi negli explananda del mio amico e severo critico Cavicchi – difficilmente possono trovare risposte compiute in un codice deontologico ma , converranno anche i critici , sono comunque al centro delle politiche della FNOMCeO.
In questa sintesi che farà sicuramente un po’ torto a tutti, ritengo che le risposte essenziali ci siano, almeno quelle che ragionevolmente e legittimamente possiamo affidare a un Codice Deontologico sul quale, lo ricordo, ricade l’obbligo di conseguire il più alto equilibrio possibile di tante diversità. Nel suo complesso e nei suoi oggettivi limiti, il nuovo Codice disegna una prospettiva di esercizio professionale attenta ai cambiamenti della Medicina, della Sanità e della Società, richiamando al Medico l’esercizio – in libertà ed indipendenza – della sua Autonomia e della sua Responsabilità nei territori tradizionali e in quelli nuovi della Professione, nel rispetto dei Principi di Beneficialità e Non Maleficità, di Giustizia e di Autodeterminazione della Persona.
La relazione di cura che, nelle scelte, diventa alleanza di cura salda questi principi in un incontro unico ed irripetibile tra medico e paziente che resta il baricentro del nostro esercizio professionale.
Ritornano poi accuse di conflitti di interesse tra il suo ruolo di Presidente FNOMCeO e Senatore della Repubblica…
Sì, a volte ritornano, e non ho nulla da aggiungere ad argomentazioni già svolte in più occasioni e rispetto le valutazioni differenti anche quando riesumano vecchi armamentari dialettici tipo le cinghie di trasmissione tra politica e professione. Parimenti vorrei che il mio impegno e la mia condizione fosse rispettata e giudicata su fatti e non su stereotipi agitati per dar maggior vigore alle polemiche.
Ricordo solo che i due unici disegni di legge che portano la mia prima firma sono la trasposizione legislativa di documenti approvati dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO sulla riforma degli ordini e la responsabilità professionale. La FNOMCeO non è una lobby ma un ente dello Stato che tutela gli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione medica ed odontoiatrica. Io sto, nell’esercizio dei miei ruoli, dentro questo perimetro di responsabilità .
Autore: Redazione FNOMCeO