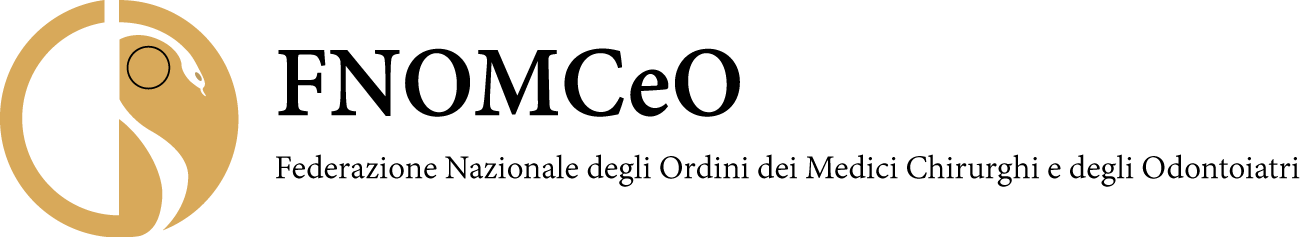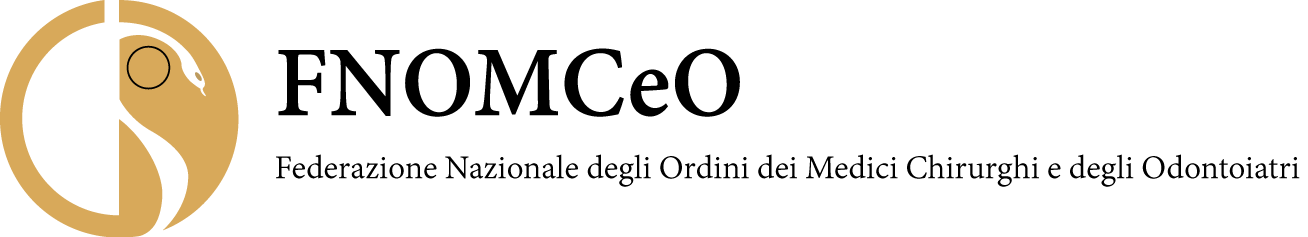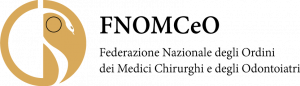La suprema Corte ha affermato che “Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell’attività riservata in via esclusiva ad esperti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute.” Nella fattispecie la Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/10/2018, aveva confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in data 05/12/2017 nei confronti di T. D. A. M. condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, per avere esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta senza avere mai conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in psicoterapia e senza essere iscritta né all’albo dell’Ordine dei medici, né a quello degli psicologi.
FATTO E DIRITTO. 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/10/2018, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in data 05/12/2017 nei confronti di T. D. A. M. condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, per avere esercitato abusivamente la professione di psicoterapeuta senza avere mai conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in psicoterapia e senza essere iscritta né all’albo dell’Ordine dei medici, né a quello degli psicologi. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputata sulla base degli atti di indagine preliminare, in particolare della denuncia di un medico il quale riferiva che la predetta T. aveva effettuato “la psicoterapia” sulla di lui figlia minore, in relazione a problematiche familiari che erano insorte. L’imputata aveva chiamato il medico al telefono comunicandogli che avrebbe intrapreso con la minore “psicoanalisi freudiana” con incontri settimanali, sconsigliando al padre di partecipare alla Prima Comunione della bambina poiché la stessa “non sarebbe stata pronta per rivederlo”. Il padre della minore, accorgendosi che la piccola non traeva alcun miglioramento dalla asserita “terapia psicologica” intrapresa con la T., compiva indagini, accertando che la sedicente psicologa esercitava abusivamente “psicoterapia”, addirittura interagendo con i componenti del Tribunale per i Minorenni. Si accertava che la stessa era titolare di partita IVA come “assistente sociale non residenziale” e non era iscritta ad alcun albo professionale, risultava invece laureata in lettere e filosofia ed effettuava “l’analisi freudiana” attraverso il metodo del colloquio e dell’ascolto. Aveva conseguito un diploma biennale ad indirizzo “handicap psicofisici della vista e dell’udito”. La T. non aveva mai dato alcuna risposta scritta al padre e non aveva risposto alle sue e -mail. La donna, inoltre, aveva deposto, in qualità di psicoanalista, davanti al giudice delegato del Tribunale per i Minorenni, quale persona informata sui fatti, interloquendo sulla “sindrome da alienazione parentale” e non escludendo che il rifiuto di vedere il padre potesse essere messo in relazione a particolari attenzioni nei suoi confronti, giudizio condiviso con una psicologa ed una educatrice che avevano avuto contatti sulla minore, anch’esse convocate dal giudice ed esaminate alla stessa udienza. Le tre persone convocate avevano risposto che “l’ipotesi così prospettata (ossia delle particolari attenzioni) non è incompatibile con le loro risultanze” (circostanza emersa da altri atti del procedimento e quindi non ipotesi formulata dalla ricorrente). La sedicente cura si era protratta per almeno due anni. 2. Ricorre per cassazione T. D. A. M. per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si fa riferimento al verbale di audizione davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17/06/2011. La Corte di appello avrebbe fornito una motivazione basata su un fatto decisivo ritenuto provato quando dagli atti di causa risulta evidente che il fatto non esiste. Questo dato, secondo la difesa, viene affermato nel provvedimento di secondo grado e non invece nella sentenza di primo grado: non emerge dal verbale che l’imputata abbia diagnosticato “la sindrome di alienazione parentale”. La Corte d’appello sarebbe incorsa in un manifesto travisamento della prova. Nel citato verbale di audizione, viene sentita la T. qualificata come “psicoanalista e analista di S.”, assieme alla psicologa e all’educatrice. La predetta aveva avuto in analisi la minore a partire dal 2009 a seguito di incarico ricevuto dalla di lei madre. In tale verbale aveva affermato che la bambina manifestava una resistenza fortissima anche solo al tema “padre”, però riteneva che non ricorresse la sindrome di alienazione parentale come teorizzata nella letteratura specializzata. Nello stesso verbale, il giudice delegato del Tribunale dei Minorenni dott. D. M., poneva a tutte e tre le persone “convocate come informatrici” una domanda attinente alla possibilità che la volontà della bambina di non vedere il padre potesse dipendere da “attenzioni” che il padre avesse avuto nei suoi confronti, cosa che sarebbe emersa in alcuni atti del procedimento (verbale del 05/09/2008) e non costituiva un’ipotesi formulata o suggerita dalla T. in quella occasione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’imputata avesse posto in essere “un atto tipico della professione di psicoterapeuta” seguendo una diagnosi di psicopatologia, così incorrendo nell’errore di travisamento della prova. Sostiene la difesa che l’attività di analisi è per definizione attività di osservazione non di somministrazione di cure e terapie e pertanto davanti al Tribunale dei minorenni essa non ha vantato un titolo che non aveva; 2) erronea applicazione della legge penale, art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Con il secondo motivo l’imputata sostiene di non avere mai speso il titolo di psicoterapeuta ma di psicoanalista e di non praticare terapia ma analisi. Anche tali discipline possono essere considerate terapie per la psiche e quindi psicoterapie soggetta alla legge “c.d. Ossicini”. Alla luce di quanto argomentato, la difesa chiede una revisione dell’orientamento fino ad ora tenuto dalla Corte di Cassazione con un’interpretazione di tipo restrittivo della norma di cui all’art. 2 della suddetta legge n. 56/89 (legge Ossicini); 3) manifesta illogicità della motivazione, art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente l’ordinanza che respinge l’eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza. Infatti, secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe richiamato la legge c.d. Lorenzin (legge 11/01/2018 n. 3) intitolata “delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” entrato in vigore il 15/02/2018: tale novella non può avere rilievo nel caso di specie essendo entrata in vigore dopo la commissione del fatto e dopo la sentenza di primo grado. Si ripropone pertanto la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra esposti. 4) violazione della retroattività della legge penale, art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Già con i motivi di appello l’imputata aveva lamentato la violazione del principio di retroattività della legge penale che la Corte non ha tenuto in debita considerazione. L’art. 348 cod. pen., in epoca precedente alla legge n. 3/2018, puniva l’esercizio abusivo di una professione che richiede una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 103,00 ad euro 516,00. Secondo la difesa, la pena irrogata si riferisce ad una norma entrata in vigore dopo il fatto commesso. La Corte avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado applicando il regime sanzionatorio dell’art.348 cod. pen., nella formulazione in vigore al momento della commissione del fatto che nel capo di imputazione veniva indicato come permanente fino al 2012. 1. I primi tre motivi di ricorso sono privi di fondamento. 2. E’ pacifico che l’imputata non ha svolto un percorso di studi né è in possesso di specifico titolo abilitante per la professione abusivamente esercitata di psicoanalista (come non risulta smentito con il ricorso), trattandosi di attività che importa l’acquisizione di un titolo abilitativo, sulla base di specifica competenza scientifica, espressione del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l’individuazione della professione protetta, irrilevante essendo la circostanza che, nel caso in esame, il soggetto agente non si presentasse come psicoterapeuta, bensì come psicoanalista, perché di fatto, ne svolgeva l’attività, secondo un proprio ciclo e ordine di sedute. In realtà, con i motivi di ricorso enunciati quali vizi della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. la difesa ricorrente intende contestare alcuni profili della ricostruzione, riguardanti il tipo di attività in concreto svolta dalla ricorrente, ma a tal fine si sofferma su un tema, quello inerente al confronto dinanzi al giudice minorile, che non risulta tuttavia decisivo, avendo la Corte valorizzato il complesso degli elementi raccolti, in particolare il ciclo sostenuto dalla minore presso la ricorrente, le indicazioni da costei fornite al padre della minore e solo da ultimo anche il confronto presso il giudice minorile, allorché fu fatto riferimento alla sindrome di alienazione parentale, nel quadro di una dissertazione rilevante ai fini delle decisioni da assumere. Ed invero il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. E’ agevole allora notare, dal confronto tra il motivo di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, che la Corte non ha fondato il suo ragionamento sulla sola dedotta circostanza (neanche il capo di imputazione ingloba questo punto); peraltro la ricorrente nel momento in cui testimonia, anche nel negare che la piccola fosse affetta dalla sindrome in discorso, si arroga di compiere una diagnosi al negativo, che a lei comunque non spetta, perché essendosi presentata come analista della bambina, non ha espresso solo una opinione (secondo me), ma un responso, espresso nella qualità per la quale era stata disposta la sua audizione e destinato ad essere valutato dall’organo giudiziario. Per completezza di esposizione, a fronte della affermazione che la ricorrente era stata convocata come psicoanalista e l’analisi è per definizione attività di osservazione non di somministrazione di cure e terapie, entrambi i giudici di merito non avevano mancato di osservare che il Tribunale per i Minorenni aveva emanato un decreto provvisorio in cui la minore doveva essere avviata ad un “percorso terapeutico” per potere riprendere i rapporti con il padre e la scelta della genitrice era caduta nella persona della ricorrente, informando il marito che era anche medico, della scelta effettuata. Dopo tale incarico la T. aveva esercitato la sua influenza professionale, avendo “sconsigliato” il padre dal partecipare alla comunione della minore che, a suo dire, non era ancora pronta per rivederlo. In concreto dunque le deduzioni sono infondate, in quanto inidonee a vulnerare la ricostruzione operata dalla Corte, sulla base dell’analisi già compiuta dal primo Giudice: di qui la valutazione in ordine allo svolgimento di attività preclusa alla ricorrente per mancanza di titolo. 3. Anche il secondo motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) viene vanamente riproposto in questa sede dopo essere stato disatteso nei precedenti gradi di merito. L’assunto difensivo dissente da quanto sostenuto dal Tribunale e dalla Corte di appello secondo cui “l’analisi costituisce pur sempre una terapia”, in linea con gli orientamenti espressi al riguardo dalla Suprema Corte. La ricorrente fa riferimento alla figura ed all’attività degli “psicoanalisti rimasti fuori dalla disciplina della legge di settore” che invece si occupa dell’attività dello psicologo. Tale tesi non può essere condivisa. Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell’attività riservata in via esclusiva ad esperti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute. In questa sede, deve essere ribadito il principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 22268 del 24/4/08 Caleffi, Rv. 240257-01) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, per rispondere al cuore della reiterata censura, “la psicanalisi”, quale riferibile alla condotta della ricorrente, va intesa come “psicoterapia”, caratterizzata da un percorso, che è anche terapeutico e volto a procurare la guarigione da talune patologie, non potendosi formulare valutazioni meramente astratte, ma dovendosi valorizzare gli elementi dai quali i giudici di merito hanno in concreto dedotto il tipo trattamento in concreto somministrato dalla ricorrente. In tale prospettiva sarebbe stata necessaria quell’abilitazione di cui la ricorrente era comprovatamente sprovvista, dovendosi ribadire la metodica utilizzata collegata funzionalmente alla psicoanalisi, deve essere inquadrata nella professione medica o di psicologo, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione (Sez. 3 n. 17702 del 2004, Bordi, Rv. 228472-01; Sez. 6, n. 14408 del 23/03/2011, Guerra, Rv. 249895-01; Sez. 2, n. 16566 dei 07/03/2017 imp. D. F., Rv. 269580-01; Sez. 6, n. 39339 del 28/06/2017, Moccia, Rv. 271083-01; Sez. 6, n. 2691 del 09/11/2017 dep. 22/01/2018, Dus, Rv. 272172-01). Né il sistema può dirsi derogato da un percorso di formazione che il singolo professionista costruisca nell’osservanza di personali e variabili modelli, attraverso l’accesso a stage e master, corsi e diplomi post laurea di vario titolo, che non possono costituire titoli equipollenti alle specifiche lauree di medicina o psicologia. Siffatte modalità contrastano con l’affermazione realizzatasi nel succedersi della normativa di settore, di un “modello legale” dettato a garanzia della formazione, nell’osservanza di tipicità e generalità dei contenuti e dei titoli. 4. Per passare al terzo motivo di ricorso, va ribadito che l’abilitazione all’esercizio della professione è elemento che attribuisce fondamento costituzionale solo a quelle rette da ordini professionali (art. 33, quinto comma, Cost.) per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio all’iscrizione in appositi albi o elenchi, fondate sull’esistenza di un effettivo interesse pubblico da tutelare. La giurisprudenza di legittimità, in applicazione degli indicati principi, ha dato, dell’esercizio della professione, integrativo del reato di cui all’art. 348 cod. pen., una lettura espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela ad interessi pubblici a protezione costituzionale. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l’art. 348 cod. pen. costituisce una “norma penale in bianco”, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo, chiarendosi come sia rimesso al legislatore ordinario la potestà di fissare condizioni aggiuntive all’esame di Stato per l’esercizio della professione, senza che tanto contrasti con l’art. 33, quinto comma Cost.. Ne consegue che, da un lato, va respinto il vizio di erronea applicazione della legge extra penale di cui all’art. 3 L. 18/02/1989 (ordinamento della professione di psicologo), essendo orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, per le ragioni sopra esposte, ritenere che la metodologia della psicoanalisi costituisca attività psicoterapeutica; una diversa interpretazione cozzerebbe sia con la normativa di cui alla L. n. 56/89, sia con gli indiscussi indirizzi giurisprudenziali, ante richiamati. Dall’altro lato, la questione di legittimità costituzionale, della norma sopra citata nella parte in cui riserva ai laureati in psicologia, l’esercizio della psicanalisi, non si fonda, nella illustrazione del motivo difensivo, su violazione analitica di precisi parametri costituzionali, bensì su affermazioni unilaterali sostenute da pareri pro ventate di consulenti di parte, essendo prospettata in questa sede in maniera del tutto generica. Ma in realtà, al di là del riferimento a pluriformi e sfuggenti definizioni, ciò che rileva è da un lato il corretto inquadramento dell’attività svolta dalla ricorrente in un ambito che coerentemente è incluso nel paradigma delle attività protette, e dall’altro la circostanza che la legge Lorenzin abbia suffragato tale impostazione, propiziata già dalla legge 56 del 1989, in tal senso dovendosi valorizzare sul punto la valutazione formulata dal Tribunale, diversa da quella, di cui si dirà, riguardante il profilo sanzionatorio: vuoi dirsi in realtà che l’attuale assetto della materia è volto ad assicurare quel razionale inquadramento che avrebbe dovuto già ritenersi desumibile in parte qua dalla legge 56 del 198 senza che possano profilarsi profili di irrazionalità, che peraltro vengono solo genericamente evocati, in rapporto al mero richiamo di norme costituzionali, senza che sia consentito un loro effettivo apprezzamento, tale da rendere possibile la formulazione di un quesito di legittimità costituzionale: la questione deve essere dunque dichiarata in radice inammissibile, anche perché in concreto non rilevante in rapporto alla complessiva disciplina vigente, qualificata dall’ultimo razionalizzante intervento. 5. Il quarto motivo è fondato. Ricorre la violazione di legge nella determinazione della pena, che deve riconoscersi come pena illegale, poiché l’art. 348 cod. pen., nella formulazione in vigore al momento del fatto contestato, prevedeva la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 103,00 ad euro 516,00. L’entità della sanzione è stata inasprita con la legge 11/01/2018, entrata in vigore dopo il fatto commesso, prevedendosi la pena detentiva da mesi sei ad anni tre e la multa da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00. Invece il giudice di primo grado ha fissato la pena base in misura illegale nella entità di mesi nove di reclusione, che deve essere annullata, con rinvio per la sua rideterminazione alla Corte di Appello di Milano, esulando tale determinazione dai poteri di questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla pena.