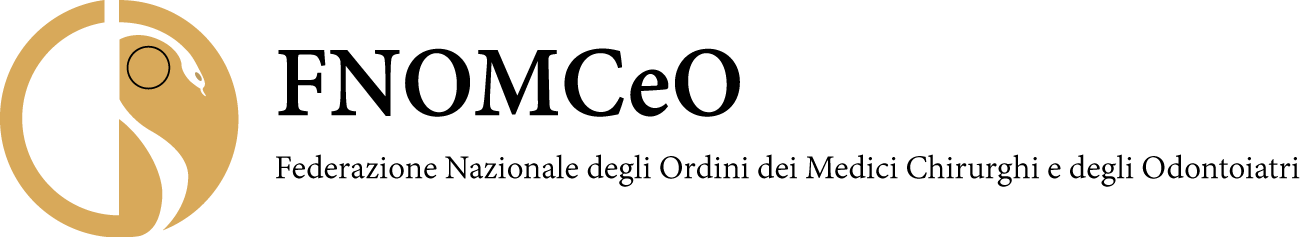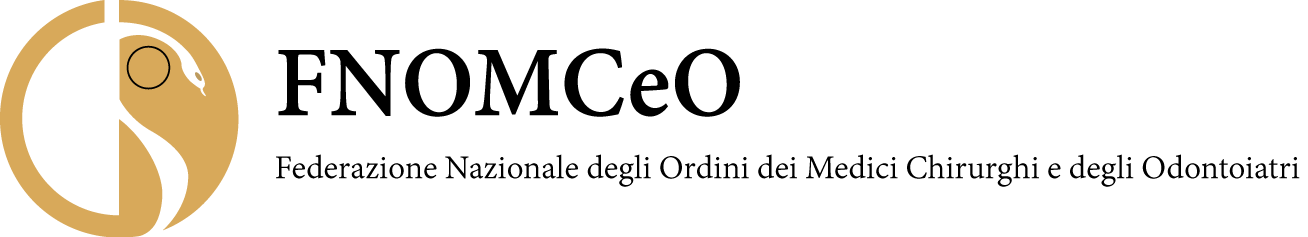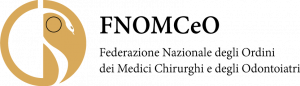La Corte di Cassazione ha affermato che “il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”.
FATTO E DIRITTO. S. S. e V. M., in proprio e in nome e per conto del figlio minore F. M. (nato con gravi malformazioni comportanti un’invalidità del 100%), convennero in giudizio il dott. G. N. e l’Azienda P. U. I di Roma per sentirli condannare al risarcimento dei danni che assumevano conseguiti al fatto che il N., che aveva seguito la S. durante la gravidanza (sia nel proprio studio che presso il P. U. I), non l’aveva adeguatamente informata sui rischi per il feto correlati ad un’infezione da citomegalovirus da essa contratta, in modo da consentirle di interrompere la gravidanza, nonché (quanto alla sola struttura ospedaliera) all’ulteriore fatto che il parto con taglio cesareo era stato effettuato dopo un prolungato e inusuale travaglio che aveva comportato una sofferenza fetale. Gli attori dedussero che, avendo contratto un’infezione da citomegalovirus, la S. -giunta alla 22^ settimana di gestazione- si era rivolta al dott. N. chiedendogli se non fosse necessario o opportuno interrompere la gravidanza in relazione alla possibilità di partorire un bambino affetto da gravi malformazioni e che il professionista l’aveva rassicurata, escludendo categoricamente l’esistenza di rischi e affermando, comunque, l’impossibilità di ricorrere all’aborto terapeutico, dato che erano decorsi i termini di cui alla I. n. 194/1978 e che non erano emerse malformazioni del feto; aggiunsero che il 6.11.1998, dopo un travaglio protrattosi per ben ventiquattro ore, la S. aveva dato alla luce il figlio F., che presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose. Si costituirono in giudizio sia il N. -che chiamò in manleva la R. M. A. (salvo rinunciare alla domanda nel corso del giudizio di primo grado)- che l’Azienda S. P. U. I, che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamò in causa l’Università L. S. (di cui l’azienda ospedaliera costituiva una struttura) e l’I. A. s.p.a.. il Tribunale di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda P.U. I in favore di quella dell’Università degli Studi di Roma L. S., rigettò la domanda degli attori e compensò le spese di lite. La Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dalla S. e dal M., anche in nome e per conto del figlio F., e ha compensato nuovamente le spese processuali. La Corte ha affermato che il primo giudice ha correttamente richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui è onere della parte che lamenti il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza allegare e dimostrare l’esistenza delle condizioni legittimanti tale interruzione ai sensi dell’art. 6 lett. b) I. n. 194/1978, ovvero che la conoscibilità dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la salute fisica o psichica della donna; tanto premesso, ha rilevato che «il tribunale ha dato rilievo all’assenza di anomalie o malformazioni, “…seppur prevedibili con un certo grado di probabilità statistica …”, fino alla 28° settimana di gestazione, quando il neonato aveva già acquisito vita autonoma» e che il «nucleo della decisione va, quindi, individuato nella mancanza di certezza di un danno rilevante ed attuale per il feto, manifestatosi solo quando non era più possibile praticare l’aborto, perché il feto godeva già di vita autonoma»; ha aggiunto che, invece, «gli appellanti anticipano il tempo di praticabilità dell’aborto al momento dell’infezione del feto, che rende altamente probabile l’insorgere di anomalie o malformazioni, a prescindere dalla loro esistenza» e ha affermato che tale lettura «non corrisponde, però, alla ratio sottesa, che tende a contemperare le esigenze di autodeterminazione della madre ed il diritto alla via del feto»; ha concluso che «i presupposti per ricorrere all’aborto sono sempre mancati fin dall’inizio» in quanto «il feto, nonostante l’infezione, era sano e tale è rimasto fino al settimo mese» e le malformazioni si sono manifestate troppo tardi, quando il feto aveva già vita autonoma; la Corte ha, infine, escluso la ricorrenza di condotte colpose nella gestione del parto, osservando che i consulenti tecnici d’ufficio avevano accertato la «conformità alla normativa vigente dell’operato dei sanitari e dell’organizzazione della struttura, in occasione del parto, escludendo ogni rapporto con le invalidità del nascituro, peraltro, già presenti circa due mesi prima della nascita» quali esiti di malattia congenita da CMV. Hanno proposto ricorso per cassazione S. S. e V. M., affidandosi a tre motivi; hanno resistito -con distinti controricorsi- il N., l’Università degli Studi di Roma “L. S.” e la G. I.s.p.a. (già ma A.); quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. Con ordinanza interlocutoria n. 12930/2020, adesiva alle conclusioni rassegnate dal P.G., il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. Hanno depositato memorie i ricorrenti, il N. e la G. I.. 1. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2043 c.c., in relazione agli artt. 6, lettera b) e 7 della I. n. 184 (rectius, 194) del 1978: premesso che «l’informazione dovuta deve essere […] comprensiva di tutti gli elementi per consentire alla paziente una scelta informata e consapevole, sia che essa sia volta alla interruzione che se sia volta alla prosecuzione di una gravidanza il cui esito potrà comportare delle problematiche da affrontare», i ricorrenti assumono che, «in presenza di un accertato processo patologico in atto, quale era l’infezione materna da CMV, il medico avrebbe dovuto rappresentare ai genitori, sin da subito, seppure in astratto e senza alcun riferimento al caso concreto, tutti i rischi teoricamente probabili (assai probabili) che l’infezione trasmettendosi al feto avrebbe determinato. Ciò senza necessità di attendere il momento in cui, in concreto, si sarebbero manifestate le prime lesioni fetali»; aggiungono che «ha erroneamente ritenuto la Corte di Appello che, accertate le malformazioni del feto derivanti da infezione da citomegalovirus in data successiva al 900 giorno di gestazione, la sig.ra S. non avrebbe più potuto sottoporsi a interruzione della gravidanza […] perché il feto aveva già possibilità di vita autonoma»; sostengono che i giudici di merito avrebbero dovuto «ritenere il processo patologico di cui alla legge n. 194/78 già in essere a seguito della insorta infezione da CMV e già accertato dal momento in cui era stata diagnosticata la malattia prescindendo, quindi, dal momento in cui questa aveva manifestato le prime anomalie fetali» e «ritenere quindi che, già al momento della prima visita eseguita sulla S. nel luglio 1998 questa, se correttamente informata, avrebbe potuto legittimamente interrompere la gravidanza in quanto in presenza di un grave pericolo per la sua salute psichica». 2. Il secondo motivo («violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 lettera b) e 7 della L. 184 del 1978 in relazione agli artt. 1218 e 2967 cod. civ., agli artt. 115 e 116 c.p.c.») censura la sentenza «laddove ha ritenuto, del tutto a priori e persino in contrasto con le risultanze istruttorie, che alla data del 9/9/1998 -momento dell’accertamento della sussistenza delle malformazioni- il feto potesse avere vita autonoma e, pertanto, che fosse esclusa per la gestante la facoltà di interrompere la gravidanza». 3. Col terzo motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello «non ha esaminato né ha deciso della ravvisata diretta responsabilità dell’Università L. S., in via solidale e concorrente con quella del dott. N., per i comportamenti a questo riferibili in virtù della responsabilità oggettiva derivante dall’avere il medico all’epoca dei fatti di causa prestato presso la struttura la propria opera professionale». 4. Con l’unico motivo -che deduce «errore in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.) in relazione agli articoli 112 e 345 c.p.c.»- la G. I. s.p.a. censura la sentenza, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, «per non essersi pronunciata sull’eccezione dell’esponente Compagnia di inammissibilità dell’appello ex art. 345 comma 1 c.p.c., nella parte in cui, in relazione alla richiesta di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo informativo indipendentemente dall’esistenza dei requisiti legali per l’esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza, ha introdotto in sede di gravame una domanda nuova»; espone che, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori avevano dedotto la responsabilità dei convenuti per aver impedito alla S. di esercitare consapevolmente il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza, mentre, con l’atto di appello, era stato richiesto l’accertamento della responsabilità per il solo fatto della mancata informazione «a prescindere se “questa potesse essere posta a fondamento della decisione di abortire”»; tanto premesso, lamenta che la Corte di Appello aveva disatteso l’eccezione, ritenendola assorbita dalla decisione di merito che aveva dichiarato l’infondatezza della domanda attorea e conclude che, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, «andrà (preliminarmente) valutato che la Corte territoriale ha tralasciato di rilevare la novità della domanda, e comunque di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.». 5. La pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti presuppone l’affermazione della possibilità legale della S. di interrompere la gravidanza oltre il novantesimo giorno di gestazione; possibilità che è riconosciuta dall’art. 6 I. n. 194/1978 -alla lett. a)- «quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna» e -alla lett. b)- «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». Premesso che, tra i «processi patologici» che possono determinare il grave pericolo per la salute della donna, la norma considera anche «quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro», il ricorso principale interroga sulla portata della previsione dell’art. 6, lett. b), dovendosi stabilire se, al fine di ritenere consentita l’interruzione della gravidanza, rilevino solo i processi patologici che risultino già esitati in accertate anomalie o malformazioni del feto oppure anche i processi patologici che possano determinare (con alta probabilità) tali anomalie o malformazioni, a prescindere dal fatto che le medesime siano state accertate, ove comunque emerga l’idoneità della stessa esistenza di un processo patologico potenzialmente nocivo per il nascituro a provocare un grave pregiudizio per la salute della donna (tale da legittimarne il ricorso all’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno e fino a quando non sussista possibilità di vita autonoma del feto). L’adesione all’una o all’altra delle due opzioni è tale da comportare esiti opposti; è evidente -infatti- che la prima conduce a ritenere (così come ha fatto la Corte di Appello) che, pur in presenza di una patologia materna idonea a determinare, con rilevante grado di probabilità, gravi malformazioni del feto, la donna che abbia superato i novanta giorni di gestazione non possa effettuare la scelta abortiva anche a fronte di un grave pericolo per la sua salute psichica (quale potrebbe conseguire alla consapevolezza di portare in grembo un feto molto probabilmente menomato); l’adesione alla seconda consente – viceversa- di accertare, caso per caso, se la stessa esistenza di una patologia potenzialmente produttiva di malformazioni fetali sia tale da determinare il grave pericolo per la salute della donna che giustifica il ricorso all’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno (e fino al momento in cui il feto non abbia acquistato possibilità di vita autonoma). 6. A questa seconda opzione interpretativa ritiene il Collegio di dover aderire. E ciò sia in base alla lettera della norma che alla luce della ratio ad essa sottesa. Va considerato, infatti, che: letta a prescindere dall’inciso concernente le anomalie o malformazioni del nascituro, la norma dell’art. 6, lett. b) della I. n. 194/78 prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata “quando siano accertati processi patologici […] che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»; l’inciso compreso tra le due virgole (“tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”) vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto; il legislatore ha dunque posto l’accento sull’esistenza di un “processo patologico” (che può anche non essere attinente ad anomalie o malformazioni fetali) e sul fatto che lo stesso possa cagionare un grave pericolo per la salute della donna; a ciò deve aggiungersi la considerazione che l’aggettivo “relativi” (riferito a processi patologici e collegato a “rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”) esprime, di per sé, un generico rapporto di inerenza fra la patologia e la malformazione che non postula necessariamente l’attualità della seconda e che consente di riconoscere rilevanza anche alla sola probabilità che il processo patologico determini il danno fetale; deve pertanto ritenersi che, laddove si riferisce a processi patologici “relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”, l’art. 6, lett. b) I. n. 194/1978 non richieda che la anomalia o la menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentalmente o clinicamente accertabile, ma dia rilievo alla circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale; deve sottolinearsi come lo stesso sintagma “processo patologico” individui una situazione biologica in divenire, che può assumere rilevanza per il solo fatto della sua esistenza e della sua attitudine a determinare ulteriori esiti patologici, a prescindere dal fatto che tale potenzialità si sia già concretamente tradotta in atto; cosicché deve ritenersi, in relazione al caso in esame, che anche la sola circostanza dell’esistenza di un’infezione materna da citomegalovirus possa rilevare al fine di apprezzare l’idoneità di tale processo patologico a determinare nella S. -compiutamente edotta dei possibili sviluppi- il pericolo di un grave pregiudizio psichico in considerazione dei potenziali esiti menomanti; nello stesso senso orienta la ratio della norma che, ponendo l’accento (come detto) sul processo patologico e sul grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, impone di riconoscere rilevanza alle situazioni in cui la patologia, ancorché non ancora esitata in menomazione fetale accertata, risulti comunque tale da poter determinare nella donna -che sia stata informata dei rischi per il feto- un grave pericolo per la sua salute psichica; deve pertanto ritenersi che un tale pericolo -da accertarsi, in ogni caso, in concreto- possa determinarsi non solo nella gestante che abbia contezza dell’esistenza di gravi malformazioni fetali, ma anche in quella che sappia di aver contratto una patologia atta a produrre, con apprezzabile grado di probabilità, anomalie o malformazioni del feto; ciò comporta, sotto il profilo dell’obbligo informativo, che il medico al quale la gestante si sia rivolta per conoscere i rischi correlati ad un processo patologico deve informarla compiutamente della natura della malattia e della sue eventuali potenzialità lesive del feto, onde prospettare alla stessa un quadro completo della situazione attuale e dei suoi possibili sviluppi; dal che consegue che l’omissione di un’informazione corretta e completa sulla pericolosità del processo patologico non consente alla gestante di acquisire elementi che -se conosciuti- potrebbero determinare nella stessa la situazione di pericolo per la salute psichica che potrebbe giustificarne la scelta abortiva; in conclusione, va disattesa, in quanto non conforme alla lettera e alla ratio della norma, una lettura dell’art. 6, lett. b) I. n. 194/78 che, inibendo l’interruzione della gravidanza fino al momento in cui non si manifesti la malformazione fetale, finisce per porre in non cale il pericolo di grave pregiudizio psichico che potrebbe determinarsi nella donna a fronte della conoscenza di processi patologici suscettibili di porsi in relazione causale (“relativi”) con rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro; per tale via, pervenendo a privare la donna, che versi in concreto in grave pericolo di pregiudizio alla salute psichica, della possibilità di determinarsi all’interruzione della gravidanza (privazione che può risultare definitiva laddove, come nel caso in esame, la menomazione si manifesti o venga accertata quando il feto abbia ormai acquisito possibilità di vita autonoma, giacché, in tale ipotesi, l’art. 7, 3 0 co. della legge consente l’interruzione della gravidanza solo in caso di pericolo per la vita della donna). Il motivo dev’essere pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte territoriale, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto: “l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della legge n. 194/78, laddove determini nella gestante -che sia stata compiutamente informata dei rischi- un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata”; “il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”. 7. Va peraltro precisato che la Corte di rinvio dovrà, nell’ordine: verificare se sia effettivamente mancata, da parte del N., una corretta e completa informazione sui rischi correlati all’infezione da citomegalovirus contratta dalla gestante (accertamento che non è stato compiuto perché la Corte territoriale ha ritenuto che l’aborto non sarebbe stato comunque praticabile); nel caso in cui detta informazione risulti mancata o carente, accertare in concreto, con giudizio controfattuale e anche mediante ricorso a presunzioni, se la conoscenza della probabilità che l’infezione da citomegalovirus provocasse danni fetali avrebbe determinato nella S. un grave pericolo per la salute fisica o psichica (costituente, come detto, un necessario presupposto legittimante il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza); nel caso in cui risultino integrate tutte le condizioni per praticare l’interruzione della gravidanza, accertare, alla stregua dei noti criteri individuati da questa Corte (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 25767/2015), se la S. vi avrebbe fatto ricorso. 8. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. 9. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato (di cui si impone l’esame a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale) è inammissibile. La ricorrente, pur ritenendo (correttamente) che l’eccezione di novità della domanda proposta in appello dalla S. e dal M. sia stata considerata assorbita dal giudice di secondo grado, prospetta un vizio di omissione di pronuncia che, tuttavia, è escluso in radice dal fatto stesso che la pronuncia sia mancata proprio in conseguenza del ritenuto assorbimento della questione, il quale comporta, per sua natura e secondo un principio di economia processuale, che non si debba pronunciare su questioni comunque “superate” (cfr. Cass. n. 4498/1996: «il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie»; conforme Cass., n. 10001/2003). Invero, una censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c. avrebbe potuto essere prospettata solo nel caso in cui la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto assorbita la questione della novità della domanda (cfr. Cass. n. 11459/2019, a mente della quale, solo l’illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 112 c.p.c.). 10. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. 11. Sussistono, in relazione al ricorso incidentale condizionato, le condizioni per applicare l’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri due motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.