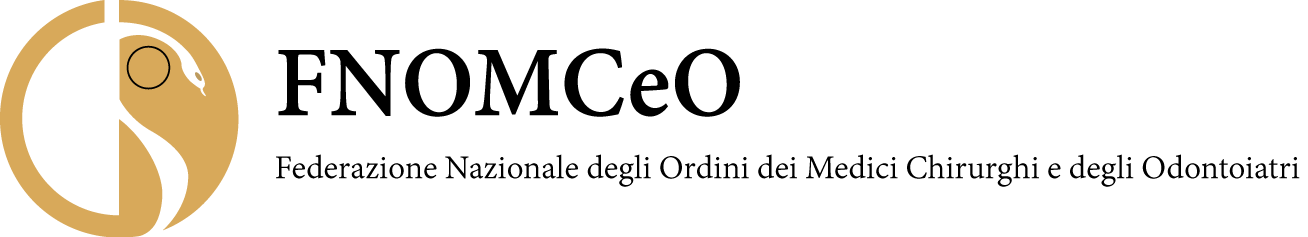«Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Servii, e vidi che il servire era gioia.»
Mi piace avviare questo convegno con le parole del grande poeta e filosofo indiano Rabindranath Tagore, Premio Nobel per la Letteratura nel 1913, una voce universale dell’umanesimo del Novecento che ci ricorda che la vita ha un senso. E che trova il suo senso proprio nel servizio.
Ma che cos’è, se vogliamo vederlo da vicino, il servizio? Cosa significa essere a servizio dell’umanità? Il termine ha delle ambivalenze di senso, di significato che possiamo riassumere in due tipologie, entrambe validissime e complementari. Da un lato, servire significa infatti essere utili: agire con competenza, rigore, conoscenza. Quando diciamo a qualcuno “mi serve il tuo aiuto” è perché chiediamo alla sua competenza di supplire a una nostra mancanza. Dall’altro, servire significa agire con dedizione, responsabilità e cura. Il bravo servitore conosce le regole del galateo, non è imbarazzato nell’armeggiare con piatti, posate, bicchieri, ordine delle portate. Aiuta i convenuti a una tavola a non esser mai in difficoltà.
Entrambi i significati, mettere a servizio il proprio sapere (le proprie competenze) e dall’altra parte mettersi a servizio – dedicarsi – prendersi cura, si adattano bene a spiegare il senso più profondo della medicina e dell’essere medico. Se, infatti, il servizio si riduce a mera competenza e rigore, esiste il rischio di perdere la sua componente umana, relazionare; la parte più nobile della nostra professione. Diventa freddo, astratto e distante. Si diventa come quei prestatori d’opera annoiati, che svolgono un compito senza alcuna interazione con la persona che hanno davanti. Un timbro e via.
Umani automatizzati, meno efficienti – spesso – del sistema automatico. Non solo, ma anche a rischio di sostituzione da un più efficiente algoritmo o intelligenza artificiale. La perdita dello spirito di servizio finisce allora con l’allontanare chi dovrebbe accogliere, perché la tecnica fine a se stessa smarrisce il senso, il significato del gesto di cura.
La grandezza e la bellezza della scienza medica risiedono nella coesistenza di entrambi i significati della parola servizio, poiché solo l’ambivalenza ci garantisce l’unione di scienza e coscienza.
Così come recita proprio il nostro Codice!
Oggi viviamo un periodo storico di evoluzione tecnologica e culturale che non ha pari nella storia dell’umanità e, di conseguenza, anche nella storia della medicina. Ogni persona presente in questa sala, che sia medico o meno, ha dovuto aggiornare una enorme quantità di competenze nel giro di
pochissimi anni, rendendosi conto di dover talvolta aggiornare, talvolta rivoluzionare conoscenze e convinzioni.
In medicina il risultato pratico di queste trasformazioni tecnologiche si traduce in una maniera molto semplice: sta cambiando la modalità con cui eroghiamo il nostro servizio ai cittadini.
C’è stato un momento emergenziale, e mi riferisco alla pandemia di COVID, in cui il ricorso sistematico alle teleconferenze ha consentito ai medici di essere quanto più possibile vicini ai cittadini pur rimanendo a distanza. È stato un momento difficile, dal quale però abbiamo imparato molto.
Abbiamo imparato che la sanità deve uniformarsi a standard europei; che la digitalizzazione dei sistemi sanitari è un vantaggio per l’operatore e per il cittadino; abbiamo appreso che il dato sanitario può e deve essere protetto come patrimonio dello Stato, per non abdicare al dovere di protezione della privacy e per consentire, secondo il dettato costituzionale, il più equo possibile ricorso ai servizi sanitari. E sottolineo la parola servizi, ancora una volta.
Oggi, passato il momento emergenziale pandemico, vediamo che la sanità sta attraversando una fase di criticità strutturale correlata alle difficoltà della finanza pubblica, certamente, ma anche a difficoltà legate ai processi di digitalizzazione, che hanno una loro ambivalenza: portano efficienza e rapidità, ma costringono cittadini e operatori ad adeguarsi a nuovi standard per ottenere il medesimo servizio che prima veniva erogato con una sua liturgia, collegata al rapporto intimo tra medico e paziente.
Il cambiamento coinvolge tutti: noi medici, chiamati a integrare nuovi strumenti, nuovi linguaggi e nuove logiche operative; ma coinvolge anche i cittadini, che si trovano a navigare su piattaforme digitali, portali sanitari e a dover familiarizzare con ambienti digitali per ottenere referti automatizzati.
Questo significa che la digitalizzazione coinvolge il rapporto medico–paziente, perché ogni innovazione modifica – in modo profondo – la trama di questo incontro. E modifica, inevitabilmente, la modalità di erogazione del servizio.
È dunque naturale che emergano dubbi e incertezze, tanto negli operatori quanto nelle persone.
La tecnologia promette molto, ma cambia le abitudini, e ogni cambiamento porta con sé una quota di inquietudine.
Vorrei però dire con chiarezza che l’incertezza, quella che proviamo quando navighiamo in mare aperto, non deve spaventarci. La trasformazione non è un elemento estraneo alla medicina: è parte costitutiva della medicina stessa.
Ce lo ricorda uno dei padri della medicina moderna, William Osler, quando affermava:
«La medicina è una scienza della probabilità e un’arte dell’incertezza».
Ecco allora il punto: la sfida tecnologica e la trasformazione delle modalità di erogazione del servizio al cittadino ci pone di fronte a un tema che dovremmo riconoscere dentro di noi, poiché fa parte del nostro patrimonio più intimo ed esperienziale: per un medico l’incertezza è il terreno storico del mestiere.
Ed è quindi questa incertezza che ci deve spingere a immaginare nuovi modi per essere di servizio. Integrando strumenti digitali e precisione scientifica insieme allo spirito di servizio.
La difficoltà che dobbiamo affrontare è la seguente: rimanere credibili nel nostro servizio in uno scenario che è descritto così nel Rapporto sulla Sanità Digitale dell’OMS. In quel rapporto si dice che più del 40% della popolazione mondiale non possiede competenze digitali di base. Il tutto mentre andiamo verso una crescente digitalizzazione dei processi sanitari.
È stato rilevato che il medico di medicina generale dedica in media dieci minuti a ogni visita. E di questi dieci minuti quasi la metà viene assorbita da procedure digitali. È un dato che deve far riflettere: più tempo per il sistema, meno tempo per la relazione.
Abbiamo la ragionevole certezza che il processo porti a maggiore efficienza. Ma quanto – e come – questa efficienza viene percepita dai cittadini? Non c’è il pericolo che la parte di servizio intesa come scienza stia cannibalizzando il senso del servizio, inteso come coscienza?
La professione medica può assolutamente navigare le acque dell’incertezza, ma non deve perdere la sua stella polare: saper custodire il senso umano della cura, anche quando cambiano i linguaggi della medicina.
Il problema, dunque, non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui la integriamo nella cura.
Come ricorda l’UNESCO nel documento Ethics of Artificial Intelligence (2022):
«Le tecnologie sono strumenti: il loro valore dipende da ciò che consentono di mantenere umano».
Ecco la nostra sfida: non lasciare che la tecnologia diventi un muro, ma farne un ponte.
La soluzione è un cambio di paradigma, nella direzione che ci illustrerà il professor Giuseppe Curigliano nella sua lectio magistralis: il passaggio da una visione riduzionista a una visione sistemica.
Non più la scienza che interviene sull’organo, ma quella che si prende cura della persona nella sua interezza, inserendo anche il benessere psicologico come endpoint primario del processo di presa in carico, cura e servizio della persona.
Un ultimo passaggio, prima di chiudere, riguarda il concetto di servizio in una sua terza declinazione: l’informazione.
Servire la scienza, oggi, significa custodirne l’integrità epistemologica: proteggerla dalle semplificazioni, dagli slogan, dalle scorciatoie comunicative.
Servire il paziente significa restare accanto a chi fa più fatica – anche sul piano digitale – senza sentirsi superiore, ma come guida.
Servire la società significa orientare la medicina verso l’equità, non solo verso l’efficienza.
L’innovazione tecnologica sta scavando nicchie di sfiducia nella popolazione e, per quanto tali posizioni siano minoritarie, rimangono comunque amplificate dall’accesso ai media e ai social media, generando confusione.
E non sono tanto le fake news, come le chiamiamo oggi, a generare problemi. Sono le mezze verità: quel mondo complesso che mescola ad arte informazioni corrette e conclusioni sbagliate, generando dubbi, sfiducia, senso di abbandono.
Essere di servizio, allora, significa trovare tempo e modo per raccontare l’evoluzione della medicina con parole semplici ma non banalizzanti. Rispettando il dubbio e accogliendolo come parte del proprio servizio che, oggi, è chiamato anche a essere di tipo educazionale.
Andiamo allora alle conclusioni, tornando al punto da cui siamo partiti: il servizio.
Il medico è chiamato a servire il cittadino, la persona, la dignità del suo sapere e lo stato dell’arte delle conoscenze mediche.
Tutto questo è essere medici ed essere realmente al servizio dell’umanità.
Il filosofo e teologo svizzero Paul Tournier, in un libro piccolo ma prezioso del 1968, intitolato La medicina dell’uomo, scriveva:
«Il più grande errore è pensare che la cura si esaurisca nella terapia».
E aveva ragione.
La cura è prima di tutto relazione, fiducia, presenza.
È spirito di servizio inteso come atto di libertà che rende il medico libero di esercitare con gioia la professione che ha scelto e la missione che si è dato.
Ufficio Stampa FNOMCeO
informazione@fnomceo.it
27 novembre 2025
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO