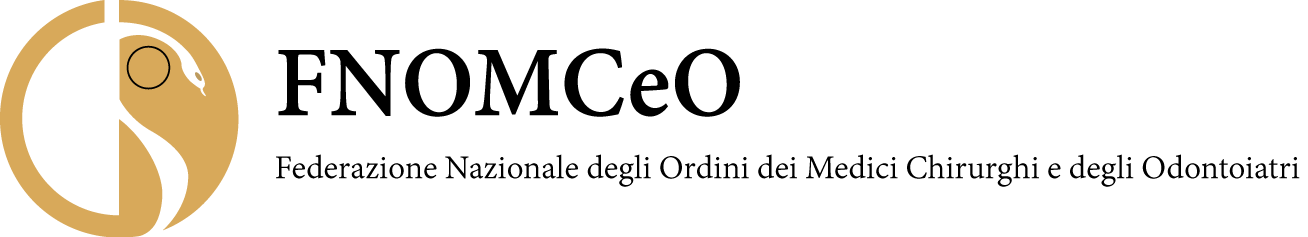È il 1914: i medici condotti, nel Regno d’Italia, sono 11554. Tutti uomini.
A rompere il monopolio maschile arriva, in quell’anno, dopo aver vinto le resistenze del prefetto e dell’amministrazione comunale di Nuoro, Adelasia Cocco che diventa, in Barbagia, la prima donna medico condotto.
Alla sua biografia Eugenia Tognotti, storica della medicina, saggista ed editorialista, dedica il libro “Del coraggio e della passione”, edito da Franco Angeli.
Non sarà, quella per l’assegnazione della condotta, l’unica battaglia di Adelasia Cocco: nata nel 1885 a Sassari, figlia di un cancelliere di Tribunale folklorista e scrittore, amico di Grazia Deledda, è tra le prime donne italiane a studiare Medicina: prima a Pisa, fuori sede grazie anche al suo status di coniugata, e poi a Sassari, dove si laurea. Dopo il contrastato accesso alla condotta, affronta a cavallo – e, più avanti, alla guida di un’automobile – strade dissetate e malsicure per raggiungere i malati. Strade sulle quali aveva perso la vita il suo predecessore, Andrea Romagna, medico conosciuto e stimato, ucciso con quattro fucilate mentre tornava a cavallo dalla frazione di Lollove. E proprio con la supplenza a Lollove Adelasia Cocco è impegnata quando scoppia la Grande Guerra, con tutto ciò che comporta per il quadro patologico della popolazione. Gli anni della guerra sono durissimi, in particolare il 1917 e il 1918, l’annus horribilis della Spagnola.
Spagnola che non deve essere mai nominata, in quanto proibita dalla censura.
 Sì, perché la lunghissima vita e l’altrettanto lunga carriera professionale di Adelasia Cocco si intrecciano con la storia, la politica il contesto sociale che va da fine Ottocento al 1954, quando Adelasia va in pensione, per prolungarsi sino agli anni ’80 del XIX Secolo, quando all’età di 97 anni, muore in un’Italia che ha conquistato il suo Servizio sanitario nazionale, con i suoi principi di universalità, eguaglianza ed equità, e dove le studentesse di Medicina superano, per numero, i ragazzi. Nel mezzo, due guerre mondiali, la dittatura fascista, alla quale Adelasia si oppone con intelligenza sottile e con silenziosa fermezza: nel 1923 fa molto rumore un suo certificato, con il quale esonera una maestra nota per le sue idee antifasciste dal presenziare alle parate in quanto “cerimonie emotive”. Negli anni Trenta la sua indisponibilità a diventare strumento della politica demografica e sanitaria del regime la espone ai continui attacchi dell’amministrazione provinciale. Con risoluta determinazione resiste al tentativo delle autorità locali di privarla del posto, faticosamente conquistato attraverso due concorsi e un biennio di prova, di direttrice del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi di Nuoro. Il lungo contenzioso si chiude con la sconfitta dei gerarchi nuoresi e il reintegro di Adelasia nel ruolo di direttrice: un’altra battaglia vinta, una prova di resilienza che rimanda alla soggettività multiforme e sottovalutata delle donne durante il regime.
Sì, perché la lunghissima vita e l’altrettanto lunga carriera professionale di Adelasia Cocco si intrecciano con la storia, la politica il contesto sociale che va da fine Ottocento al 1954, quando Adelasia va in pensione, per prolungarsi sino agli anni ’80 del XIX Secolo, quando all’età di 97 anni, muore in un’Italia che ha conquistato il suo Servizio sanitario nazionale, con i suoi principi di universalità, eguaglianza ed equità, e dove le studentesse di Medicina superano, per numero, i ragazzi. Nel mezzo, due guerre mondiali, la dittatura fascista, alla quale Adelasia si oppone con intelligenza sottile e con silenziosa fermezza: nel 1923 fa molto rumore un suo certificato, con il quale esonera una maestra nota per le sue idee antifasciste dal presenziare alle parate in quanto “cerimonie emotive”. Negli anni Trenta la sua indisponibilità a diventare strumento della politica demografica e sanitaria del regime la espone ai continui attacchi dell’amministrazione provinciale. Con risoluta determinazione resiste al tentativo delle autorità locali di privarla del posto, faticosamente conquistato attraverso due concorsi e un biennio di prova, di direttrice del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi di Nuoro. Il lungo contenzioso si chiude con la sconfitta dei gerarchi nuoresi e il reintegro di Adelasia nel ruolo di direttrice: un’altra battaglia vinta, una prova di resilienza che rimanda alla soggettività multiforme e sottovalutata delle donne durante il regime.
E proprio delle donne, della possibilità di conciliare la carriera con la vita familiare, Adelasia, moglie felice di Giovannico Floris, veterinario, e madre di tre figli, uno dei quali morirà di scarlattina, divertita dalla moda e perfetta padrona di casa all’occorrenza, sarà, con l’esempio e con i con i fatti, grande sostenitrice. Nel 1965, ormai anziana, rinuncia, “per delicatezza”, lei che non aveva esitato un istante a opporsi a uomini di potere, all’ultima battaglia, perché avrebbe dovuto combatterla contro una collega. In quell’anno, infatti, “Anno mondiale della donna” indetto dall’Onu, la Fondazione Carlo Erba attribuisce il Premio “Missione del Medico” a Isotta Gervasi, romagnola, conosciuta come la “dottoressa in bicicletta”. E, nei comunicati stampa, la definisce “primo medico condotto d’Italia”, anche se lo era diventata cinque anni dopo Adelasia Cocco, nel 1919. Adelasia, pura amareggiata e delusa, rinuncia a rivendicare il suo “primato”. Ma la prima donna italiana a diventare medico condotto – superando un muro roccioso di tabù, pregiudizi e resistenze in un’isola prigioniera del mare – era stata lei, Adelasia Cocco.
Ora Eugenia Tognotti, “grazie alla sua appassionata scrittura e alla ricchezza di materiali e documenti d’epoca”, come scrive Rosy Bindi nella prefazione al libro, le rende giustizia, riportando alla luce la sua vicenda che, intrecciandosi con quella delle prime donne medico, diventa un racconto collettivo e uno spaccato della vita sociale e politica del Paese che attraversa due secoli.
A cura dell’Ufficio stampa FNOMCeO
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO