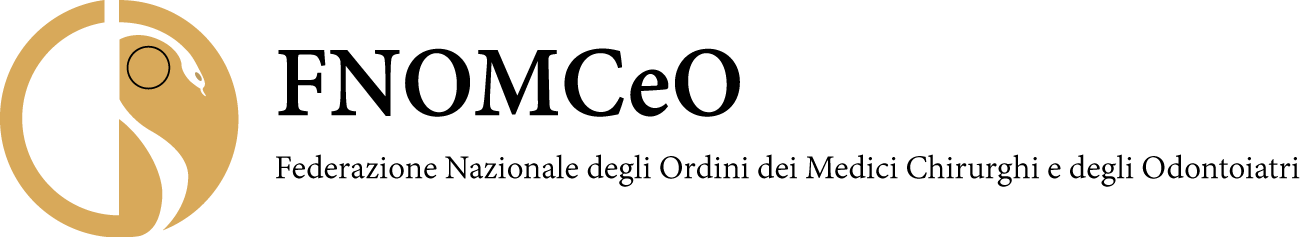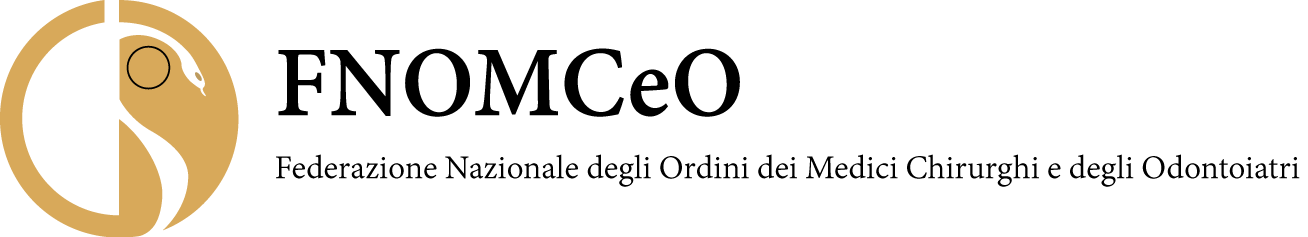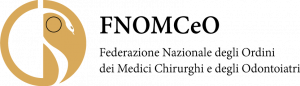Gentile Direttore,
all’interno della discussione sugli “Stati Generali” della medicina ha ripreso vigore la questione dell’Atto medico che sembrava sopita. Una vecchia storia che ha impegnato a lungo il Consiglio Nazionale da quando gli infermieri, d’accordo con i medici di molti ospedali, hanno cominciato a vedersi affidare atti inerenti le loro competenze ma che ad alcuni dirigenti sembravano sottrarre spazio professionale alla categoria e configurarsi come esercizio abusivo della professione, quindi contro l’interesse dei pazienti.
Si cominciò con il see and treat toscano cui seguirono, sempre in Toscana, i protocolli del 118 e, nel tempo, una serie di atti professionali concordati in diverse situazioni che hanno fortemente preoccupato alcuni presidenti di Ordine fino a chiedere, nella scorsa legislatura, un’apposita legge che definisse l’atto medico. Escluso i protocolli del 118, questo fenomeno avviene al di fuori delle istituzioni regionali.
E’ la questione del cosiddetto “task schifting“, che a me sembra una discussione inutile. In ogni parte di Italia, senza chiedere permesso ad alcune autorità, medici e infermieri, nel disegnare percorsi assistenziali, decidono chi fa che cosa, ovviamente nell’ambito del buon senso e delle competenze acquisite.
Sono convinto che definire con legge l’atto medico sia inutile e dannoso perché, in presenza di curricola formativi spesso embricati e di competenze confinanti, per quanto nessuno proporrebbe agli infermieri diagnosi differenziali o atti chirurgici, tuttavia qualsiasi norma potrebbe scadere facilmente a mansionario che la legge non ha mai previsto per i medici e ha abolito per gli infermieri.
Lasciamo decidere al magistrato che altrimenti, in presenza di una legge e trattandosi pur sempre di professioni “protette” per il cui esercizio occorre un titolo, potrebbe decidere che per eseguire una iniezione intramuscolare occorre essere infermiere. In termini di diritto non sempre dove va la nave va anche il navicello.
Mi sembra che ora se ne voglia uscire parlando di “agire medico”. “Agire” significa genericamente operare o comportarsi; “azione” è un’operare sorretto da una volontà, “atto” è la manifestazione esterna di una volontà, compiuta e quindi spesso aggettivata da un giudizio morale (atto disumano, crudele, religioso, medico). “Atto medico” quindi significa atto di cura “actus medendi”, ma spesso le iniezioni domestiche (le bucature) le fanno le vecchie zie.
E’ ovvio che quando si parla di atto medico si intende “atto del medico” ma anche questo soddisfa poco. Infatti molti atti sono a comune con altre professioni ad esempio le endovene. Forse meglio sarebbe specificare “atto proprio del medico”, il che ricomprenderebbe un “agire” cioè un comportarsi secondo regole peculiari della professione.
Ma cosa è peculiare del medico? Sono peculiari molte prestazioni intellettuali e manuali, più che altro è propria del medico l’interpretazione dei fatti che hanno a che fare con la tutela della salute individuale e collettiva. Quindi ogni diagnosi beyesiana o ermeneutica, ogni atto invasivo e molte altre cose. Ma ha senso elencarle? Perché ogni elenco comporta il suo contrario e crea una sorta di riferimento ontologico che necessita di adattamento caso per caso e siamo da capo.
In un mondo che, globalizzandosi, privilegia le competenze sui titoli, saper fare una prestazione e non averne il titolo è più o meno abusivo che non saperla fare e farla perché si ha il titolo? Il medico è il responsabile del percorso assistenziale e assegna, ovviamente in modo condiviso, i compiti all’interno di questo a seconda delle competenze di ognuno.
Insomma le definizioni hanno un grosso margine di rischio. Il medico, laureato e iscritto all’albo, può svolgere qualsiasi prestazione nell’interesse dell’individuo e della collettività, purché questa sia accettata dalla comunità scientifica e ricompresa nelle regole della deontologia. Così è più semplice e chiaro.
Antonio Panti
Lettera pubblicata su QuotidianoSanità
Autore: Redazione