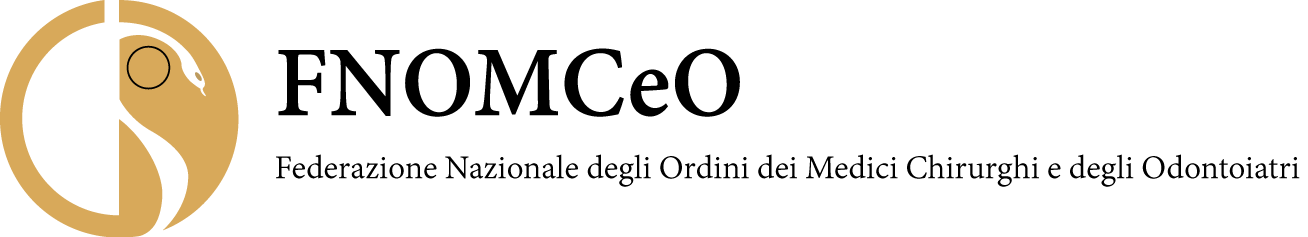Care colleghe e cari colleghi,
arriviamo alla conclusione di questi due giorni intensi con la sensazione – spero condivisa – che il titolo del nostro convegno non fosse soltanto un’intestazione, ma un impegno.
Essere al servizio dell’umanità è infatti un impegno forte, che presuppone uno spirito di servizio che non conosce frontiere di alcun genere. Mi riferisco a quelle geografiche, ma vorrei sottolineare anche altre barriere: culturali, etniche, sociali. Se la scienza medica ha come oggetto l’essere umano e si mette al suo servizio, non è possibile operare distinguo. Non possiamo fare un metaforico triage tra chi è più e chi è meno degno del nostro spirito di servizio.
Ieri abbiamo aperto i lavori riflettendo sulla parola “servizio”, nelle sue diverse declinazioni. Oggi possiamo dire che quella parola ha trovato forma concreta nei contributi che sono giunti a noi nelle forme più diverse: dalle prospettive cliniche alle nuove tecnologie, dalla dimensione etica – non ultima – a quella istituzionale.
Dietro ognuna di queste visioni restano i bisogni insoddisfatti delle persone: il vero orizzonte della nostra missione. Come possiamo dare una risposta a questa richiesta, come possiamo affrontare il grande tema dei bisogni insoddisfatti? Per farlo useremo un metodo di indagine molto noto: quello del rasoio di Occam, principio metodologico che suggerisce di preferire le teorie più semplici per la soluzione di un problema, tagliando via i concetti superflui, a maggior ragione in ambito scientifico.
Cominciamo allora con lo stabilire alcuni punti chiave emersi dall’indagine dell’Istituto Piepoli, che ci consegnano una fotografia nitida – e per molti versi sorprendente – del rapporto fra gli italiani e la scienza. Una fotografia che contiene un dato fortissimo e un punto di attenzione.
Il dato fortissimo è la fiducia.
Il 90% degli italiani considera la scienza un motore di progresso e sviluppo, l’86% ripone fiducia nella medicina, e l’81% dichiara fiducia nel proprio medico di famiglia. Sono percentuali che, lette insieme, ci dicono che l’Italia non è un Paese diffidente. Al contrario: è un Paese che riconosce nella scienza una bussola e nella medicina un presidio di sicurezza, di equità, di ordine.
Tuttavia, questa fiducia così solida si incrina quando la conversazione tocca un punto preciso: i vaccini. È qui che la quota di diffidenza cresce, arrivando a coinvolgere quasi un terzo della popolazione quando si parla di vaccini a mRNA. È una frattura che non può essere ignorata. E non può essere letta come rifiuto della scienza, perché i dati ci dicono il contrario: gli italiani credono nella scienza, credono nella medicina, credono nella ricerca. Ciò che temono, piuttosto, è la perdita di orientamento.
Stiamo parlando della grande confusione del nostro tempo: una sovrapposizione continua tra informazioni corrette, mezze verità, narrazioni distorte, rapide e aggressive, amplificate all’ennesima potenza da canali che non distinguono la competenza dalla rumorosità ovvero l’arte di sommergere l’interlocutore con una quantità di dati, affermazioni e pseudo-evidenze tale da impedirgli qualsiasi verifica immediata. È un metodo collaudato per creare l’illusione della competenza e spostare sull’altro l’onere della confutazione.
La ricerca Piepoli ci dice chiaramente che questo meccanismo produce conseguenze profonde: non sfiducia, ma disorientamento; non rigetto della scienza, ma paura di non comprenderla più, soprattutto quando la tecnologia corre più veloce della capacità collettiva di interpretarla.
Eppure, in questo scenario, emergono anche segnali straordinari.
L’87% degli italiani sa che la ricerca scientifica ha allungato la vita; il 67% vede nelle tecnologie mediche un’opportunità straordinaria; il 68% sarebbe disposto a ricorrere a un vaccino a mRNA contro i tumori se ne avesse bisogno. E quando si parla di malattie genetiche nei bambini, il quadro diventa persino più nitido: l’88% ritiene giusto che lo Stato garantisca terapie ad altissimo costo per la SMA; l’83% afferma che “ogni vita conta”; il 63% dice sì alla terapia genica se evita sofferenze.
Non è un Paese impaurito.
È un Paese che chiede di essere accompagnato nel cambiamento.
È un Paese che accetta l’innovazione quando riesce a intravedere la relazione, l’intenzione, il senso.
E c’è un altro messaggio forte, che attraversa tutta la ricerca: gli italiani sanno che salute e ambiente sono inscindibili. L’84% è convinto che tutelare la natura significhi prevenire malattie; l’88% ritiene che l’ambiente debba far parte integrante della sanità pubblica. Anche qui, la direzione è chiara: non si chiede una medicina chiusa dentro i confini dell’ospedale, ma una medicina capace di guardare al contesto, alle condizioni di vita, all’ecosistema in cui le persone nascono, crescono, lavorano, respirano.
E infine: l’87% degli italiani afferma che la professione del medico contribuisce al progresso della società, e il 72% immagina che tra dieci anni vivremo in un mondo più protetto dalle malattie. Non è solo fiducia: è una forma di speranza ragionata, informata, realistica.
Questi dati ci consegnano un compito preciso: diventare mediatori di complessità.
Non meri tecnici, non soli clinici, non ripetitori di linee guida: ma interpreti dei linguaggi nuovi che la scienza e la tecnologia ci offrono.
La società ci sta chiedendo questo: non di semplificare ciò che non può essere semplificato, ma di renderlo comprensibile senza tradirne il significato; di custodire il rigore senza rinunciare all’empatia; di proteggere la qualità dell’informazione senza perdere il contatto con le persone che ci chiedono di orientarle, non di giudicarle.
Ed è qui – proprio qui –-che deve emergere con forza il ruolo del medico.
Siamo chiamati a interpretare il cambiamento, non a subirlo; a guidare l’informazione, non a inseguire la disinformazione; a spiegare i mutamenti di paradigma, non a farli cadere dall’alto come dati di fatto.
Ma per rendere prassi operativa e quotidiana ciò che abbiamo appena detto, che cosa dobbiamo fare davvero? La risposta, strano a dirsi, viene ancora una volta dall’India, dopo la citazione di Tagore di ieri. In questo caso la citazione è di Gandhi: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo».
Noi lo abbiamo visto in questi due giorni.
Lo abbiamo visto quando il professor Curigliano ci ha parlato di una “nuova epistemologia medica” che va oltre il riduzionismo per abbracciare una visione sistemica.
Lo abbiamo visto nelle terapie di precisione illustrate dalla professoressa Lasorella, che ci confermano come i percorsi di cura siano sempre più mirati, più rispettosi dell’unicità di ogni paziente e quindi più efficaci.
Lo abbiamo scoperto grazie agli interventi del professor Prattichizzo, che ci hanno ricordato come la robotica sia un alleato formidabile, purché resti chiara una cosa: la tecnologia sostiene il medico, non lo sostituisce.
E lo abbiamo ribadito attraverso le preziose riflessioni del professor Tabaton sull’Alzheimer, che ci hanno indicato come la diagnosi precoce stia aprendo nuove possibilità in un ambito in cui per anni ci siamo sentiti impotenti.
Ne abbiamo avuto riprova grazie al professor Ciceri, che ci ha riportato alle radici della professione, mostrando come i paradigmi cambino, ma la responsabilità resti sempre la stessa.
Lo abbiamo ulteriormente fatto nostro grazie all’intervento del dottor Arcioni sulla terapia genica, che ha reso evidente come abiti già nel presente quell’orizzonte che molti di noi collocano ancora nel futuro.
E lo abbiamo poi confermato con il professor Rappuoli, che ci ha ricordato come le grandi sfide globali – la resistenza antimicrobica, la preparazione alle pandemie, l’equità di accesso alle cure – richiedano una medicina capace di guardare lontano.
E, non ultimo, con il professor Gori, che ci ha introdotti nella sfida della clinica medica con i cosiddetti assistenti artificiali derivanti dalla incredibile opportunità che offre l’intelligenza artificiale e con il professor Bucci che ci ha parlato di un’altra sfida, quella della medicina “evidence based” che deve difendere la sua integrità da pregiudizi, interessi, false credenze, per non diventare “evidence-biased”.
È stata una due giorni di lavori che può essere letta in due modi: uno appartiene al passato, l’altro al futuro, passando attraverso le valutazioni del presente.
La lettura del passato è quella specialistica e di parcellizzazione del sapere.
La lettura del domani, che già oggi dobbiamo iniziare a comprendere e a fare nostra, è quella dell’interdisciplinarità dei saperi, che concorrono a formare una classe medica rinnovata negli strumenti grazie alla tecnologia, ma rinnovata anche nell’esigenza di servizio, riscoprendo come centrale la necessità della relazione.
Ecco perché, alla domanda centrale posta ieri da monsignor Pegoraro – «ci sarà ancora bisogno del medico?» – la risposta non può che essere affermativa.
E lo diciamo forti del fatto che lo spirito di servizio, di cui abbiamo molto discusso ieri, non può prescindere dal senso di responsabilità. E questo appartiene indiscutibilmente al regno dell’umano – e quindi del medico – a prescindere da ogni ausilio tecnologico egli possa utilizzare per fare ricerca, diagnosi o somministrare terapie.
È nei sistemi umani che possiamo costruire la fiducia. Lo ha spiegato con parole cristalline Carl Gustav Jung, di cui vi sottopongo due passaggi:
«La fiducia è un risultato dell’incontro: nessuno può costruirla da solo.»
E ancora:
«Ogni processo di guarigione richiede una relazione umana. Senza un rapporto autentico, non c’è trasformazione.»
Siamo dunque arrivati alla fine del convegno, che coincide con l’inizio di un percorso.
Questi due giorni ci hanno consegnato tre consapevolezze:
- La scienza è forte, ma la fiducia può essere fragile.
Sta a noi custodirla, accrescerla, coltivarla, rassicurarla. - La medicina è sempre più avanzata, ma richiede più umanità, non meno.
Sta a noi garantirla, preservando la relazione e il patto di fiducia che abbiamo appena citato. - Il cambiamento è rapido, complesso, a tratti disorientante.
Sta a noi interpretarlo da un punto di vista professionale e diventare interpreti dei linguaggi nuovi che la scienza ci offre, per continuare a preservare fiducia e umanità.
Servire l’umanità oggi significa proprio questo:
unire competenza e responsabilità, innovazione e relazione, precisione tecnologica e delicatezza umana.
Significa ricordare che la cura – come abbiamo detto ieri – non si esaurisce nella terapia.
Che ogni persona ha una storia.
Che ogni gesto, anche il più piccolo, costruisce fiducia o la distrugge.
Se saremo capaci di abbinare il rigore della scienza con la forza della coscienza, il nostro obiettivo potrà dirsi raggiunto e il nostro servizio è destinato a essere – e a portare – gioia.
Grazie.
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO