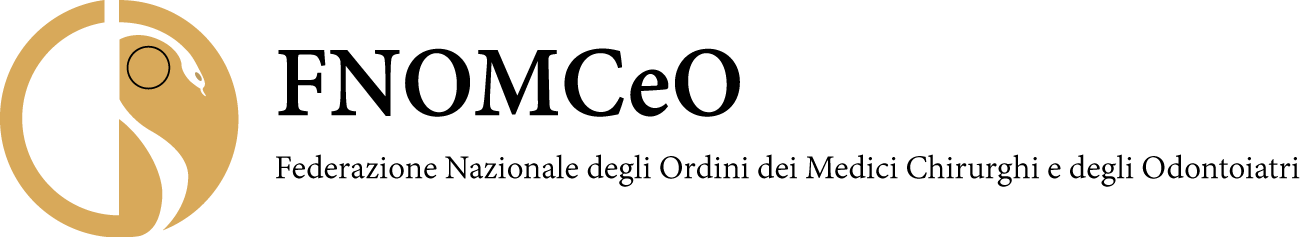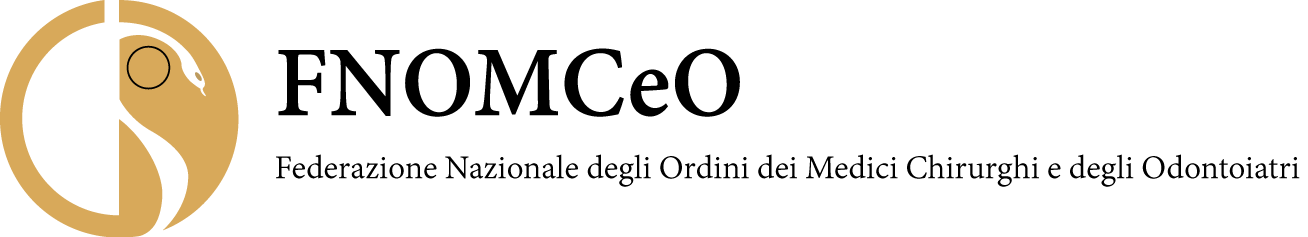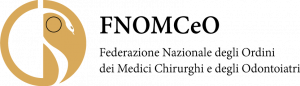Lo stile dell’abuso. Violenza domestica e linguaggio
Roma, Treccani, 2021
Intervista all’autrice, Raffaella Scarpa, Docente di linguistica medica e clinica presso l’Università degli Studi di Torino
Tra i tanti punti di vista dai quali si analizza il fenomeno della violenza domestica nessuno è stato più sottovalutato del linguaggio. Eppure, l’uso delle parole, la loro combinazione, lo “stile del discorso” costituiscono invece il mezzo fondamentale di cui l’abusante si avvale per ridurre e mantenere la donna in uno stato di soggezione e soccombenza. Oggi la violenza è un ampio contenitore mediatico e non solo. Ma è spesso difficile orientarsi per non rischiare di essere parziali e incompleti. Esiste una particolare forma di male subito che fa dell’assenza di ragione il suo principio costituente, e questo è insito nella violenza domestica.
 Professoressa, come nasce il percorso che ha portato a trattare un tema così discusso da un punto di vista nuovo, cioè la prospettiva linguistica?
Professoressa, come nasce il percorso che ha portato a trattare un tema così discusso da un punto di vista nuovo, cioè la prospettiva linguistica?
La lingua degli abusanti, la forma che prendono le loro parole quando si rivolgono alla loro compagna in effetti non era mai stato oggetto di indagine. Occorre un orecchio ben addestrato – quello dei linguisti in genere lo è – per intercettare quelle piccole incrinature che caratterizzano il discorso maltrattante che invece appare assolutamente normale.
Mi piace studiare i comportamenti linguistici “estremi” (la lingua del delirio, della follia, del fine-vita, della violenza ecc.) proprio per ciò che si nasconde sotto le parole. Ricordo una testimonianza, vado a memoria ma il senso è questo: “non capisco ancora adesso cosa nel suo modo di parlare mi facesse così paura, non c’era nulla di strano eppure mi paralizzavo”.
Professoressa, sappiamo che per il grande pubblico la linguistica è molto connotata, spesso confusa con una disciplina che si occupa della correttezza grammaticale, della competenza lessicale o sintattica o della didattica delle lingue straniere. Possiamo fare un po’ di chiarezza?
Certo, mi è capitato diverse volte di essere scambiata per una ‘maestrina dalla penna rossa’ o di una insegnante di lingue straniere. La linguistica è molte cose; la mia linguistica è un sapere che usa sonde di profondità per scoprire le latenze, il non detto, la forza ignota che struttura ciò che scriviamo e diciamo e che non è chiara, spesso, neppure a noi.
Molti anni iniziai a studiare la lingua della psicosi presso il reparto di psichiatria dell’Amedeo di Savoia di Torino, quella fu una straordinaria occasione che mi costrinse a impegnarmi a comprendere quali verità nascondeva la lingua del delirio. È stata proprio questa esperienza che mi ha dato la possibilità di esercitarmi al dissotterramento dei significati profondi del testo, per questa ragione la mia passione per la stilistica.
A questo proposito, lo stile non è un concetto semplice. Come lo si riconosce?
Lo stile non è certamente un concetto semplice, soprattutto quando non è applicato al testo letterario. Io ho rimodulato il concetto di analisi stilistica che, nella nostra tradizione, è un metodo applicato essenzialmente ai testi letterari, pensandolo per i testi non letterari.
L’analisi linguistica è la mappatura del testo (sul piano grammaticale, testuale, retorico, logico-argomentativo) mentre l’analisi stilistica attribuisce un valore aggiunto, cioè individua uno stilema, ovvero quella figura linguistica che dice più del suo significato grammaticale: mette in relazione la struttura della lingua con l’istanza profonda che la genera, cioè mette in risonanza la matrice profonda del parlante e funziona proprio come una sorta di “macchina della verità”. In estrema sintesi l’analisi stilistica lega il soggetto alla sua propria lingua in maniera stretta e incontrovertibile.
Nel caso della violenza domestica, soltanto i sensori acutissimi della stilistica potevano essere in grado di cogliere ciò che deve per agire sotto traccia e per non essere disinnescato.
Il testo è carico di testimonianze forti. Lei ha toccato biografie con garbo ma senza risparmiare le ferite, ma ribadisce sempre che ha filtrato il “troppo”.
Questo lavoro di ricerca dura da circa 20 anni. Non in modo continuativo e dedicato. Ma diluito col tempo, diluendo anche l’ascolto di queste testimonianze. Questo tempo aiuta anche ad assimilarle. Io ho scelto di non appoggiarmi ad una rete istituzionale, ma ho cercato storie ad alta grado di autenticità. Volevo essere un interlocutore libero, svincolato da un ruolo codificato.
Il numero dei casi non è infinito, ma la tipologia è molto ricca. E ho trovato persone – abusate e abusanti- che hanno messo a disposizione la loro storia e le loro parole, il libro l’hanno fatto loro, lo dico senza alcuna retorica. Ho dovuto ovviamente tagliare molti dettagli per la protezione della privacy, ma anche le parti più dure per rispetto al tollerabile. Non volevo perpetrare il gioco dell’abuso. Lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni sui media: insistenza su particolari, morbose descrizioni che col tempo rischiano di agevolare proprio il meccanismo stesso della violenza, anestetizzando progressivamente il senso del limite, del tollerabile.
A questo proposito lei scrive nella dedica: “Dedicato a chi non sa riconoscere l’intollerabile”…
Non ai fragili, ma a chi non riconosce l’intollerabile. Questa differenza è importante. Non è un appello a chi è in condizione di fragilità, ma a chi non è – non riesce, non può – essere in ascolto di sé e ascoltare il mondo e la realtà dei fatti.
Non è possibile che le campagne di comunicazione confondano i piani, rendendo ancora più fragili soggetti che non lo sono. Stiamo sbagliando a costruire un immaginario in cui se non appartieni ad una iconografia di donna o persona distrutta o umiliata, allora non rientri nel repertorio di immagini che riportano alla violenza domestica. L’ideologia vittimaria è oggi il primo travestimento delle ragioni dei forti.
Potere, violenza, linguaggio. Pensiamo alla relazione medico-paziente: possiamo riflettere su quando ci siamo detti – in modo traslato e rimodulato? La relazione medico-paziente da sempre è la rappresentazione di un potere istituzionalizzato. In cui la soggezione del sottoposto (paziente) non è prodotta, ma è reale. Noi tutti sappiamo quanto le parole di un operatore sanitario riverberino, come delle onde sonore che appartengono ad un’altra lingua, con derive di significato infinito quando siamo in un contesto di assistenza, in una condizione di fragilità. A volte determinate espressioni generano un ottundimento, una sorta di dolore che non sappiamo da dove arriva. E si entra in una confusione protettiva.
Ovviamente in questo contesto non si ha a che fare con l’abuso, ma comunque con una condizione di potere che può generare dolore e a volte una sorta di paralisi afasica.
Professoressa, come possiamo rilanciare la riflessione?
Possiamo dire che dobbiamo forse ripartire dalla definizione. E non sono sicura che la categoria di violenza sia adeguata per descrivere queste diverse condizioni di abuso. Spesso negli studi si attesta che gli atteggiamenti violenti sono riconoscibili. Ma nella violenza domestica non è così, soprattutto nei casi in cui la lesione non è fisica, o non soltanto fisica. È “lo stile dell’abuso” – che è essenzialmente una macchina linguistica di menzogna, manipolazione, assoggettamento e annichilimento – che crea le pre-condizioni per la violenza comunemente intesa.
Autore: Redazione