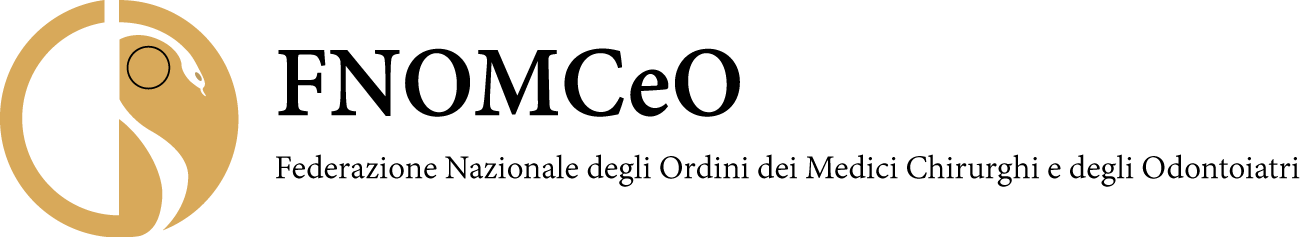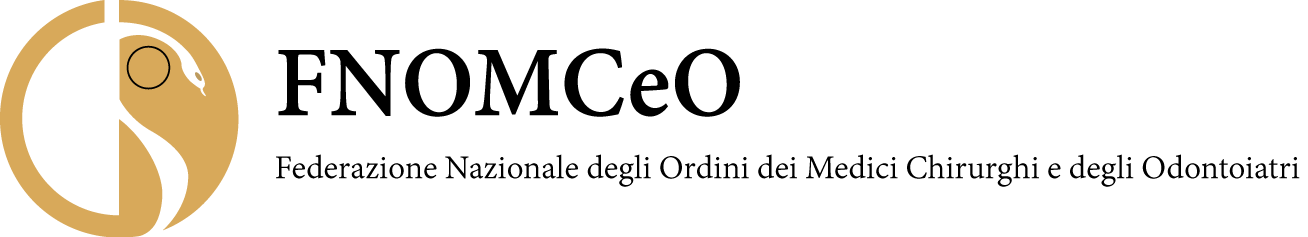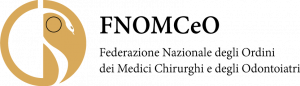Questi giorni sollecitano necessarie riflessioni sulla storia e sulle tracce mnestiche che rischiano di diventare sempre più sbiadite. Riproponiamo un commento dello studioso Andrea Carlino, professore Ordinario di Storia della Medicina presso l’Università di Ginevra, pubblicato sul Portale FNOMCeO nel 2015.
Storia e memoria: due poli sempre più distanti. Ma la medicina conserva una dimensione propria della memoria?
La parola zakhor, in ebraico, significa “ricorda”. È un verbo che ricorre nell’Antico Testamento e che, in particolare nel Deuteronomio, diventa un’ingiunzione: il testo sacro istituisce il dovere della memoria per il popolo ebraico. Una trentina di anni or sono, lo storico Yosef Yerushalmi ha dedicato a questa parola un libretto, da poco ripubblicato in italiano: Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica. È un testo esemplare che pone il problema della divergenza essenziale tra storia e memoria, mostrando come il dovere della memoria per il popolo ebraico si accompagna a una sorta di pregiudizio degli ebrei verso la ricostruzione e la narrazione della storia, un pregiudizio che può essere superato unicamente attraverso la secolarizzazione del passato, attraverso il superamento della dimensione rituale e sacra del ricordo. Questa tensione trastoria e memoria non è un carattere esclusivo della cultura ebraica.
A mio modo di vedere, essa, in forme diverse, è ravvisabile in ogni ricostruzione del passato: del passato (personale, collettivo, professionale, nazionale, etnico) ciascuno ha e fabbrica una memoria che assume una dimensione per così dire sacra quando essa struttura e corrobora le nostre identità; questa ricostruzione soggettiva (singolare o plurale, poco importa) non coincide necessariamente con quella tendenzialmente oggettiva, distanziata, critica che la ricerca storica prova a fornire. È un po’ quanto si constata anche guardando al modo in cui la medicina pensa al proprio passato. Anche in questo caso quegli elementi che costituiscono la memoria individuale e collettiva dei medici, ciò che costituisce hic et nunc la loro identità in qualità di membri attivi di un corpo professionale, spesso non coincidono con quanto una storiografia laica (ovvero non interna al corpo professionale) fornisce sulla base di una ricerca documentaria meticolosa, grazie a strumenti d’analisi raffinati e grazie a un distanziamento che consente di problematizzare criticamente l’oggetto di studio. Per questa ragione considero che la storia della medicina debba essere fatta da storici professionisti. Ciò non significa affatto assegnare alla dimensione memoriale una connotazione negativa e a quella storica una positiva, né attribuire maggiore rilevanza all’una a discapito dell’altra.
Naturalmente anche studiare la memoria, i meccanismi attraverso cui una memoria si costituisce e il modo in cui essa modella il nostro agire sono di estremo interesse.
Con un gruppo di colleghi di orizzonti disciplinari molto diversi stiamo appunto studiando un fenomeno, il tarantismo, tanto nei suoi aspetti storici, quanto nella memoria contemporanea cercando di mostrare appunto la complessità della relazione tra storia e memoria. Il tarantismo è una sindrome che si credeva determinata dal veleno di un ragno (la tarantola, appunto) e che era tradizionalmente curata con la musica ancora sino agli anni Settanta del XX secolo. Questo male, che appartiene alla cultura popolare del Salento ed è fortemente vincolato all’identità locale, è diventato oggetto di curiosità e di studio, un case study, quasi un enigma per intere generazioni di medici in tutta Europa, dal Seicento sino ad oggi, che hanno offerto diverse interpretazioni mediche. In nome della scienza, essi hanno per lo più preteso di prescindere dagli aspetti contestuali e culturali del fenomeno, hanno provato a ridurlo ad un fenomeno patologico. Noi cerchiamo di studiare la storia di queste interpretazioni, oltre che del tarantismo stesso, ma anche quanto oggi costituisce la memoria viva di questo fenomeno e i modi in cui le comunità locali, ancora oggi, utilizzano questa memoria. Inutile dire che i tentativi plurisecolari di medicalizzazione del tarantismo non hanno lasciato traccia alcuna nella memoria contemporanea…
Il ricordo dovrebbe poter affondare nella tradizione: che rapporto oggi tra ricordo e tradizione?
Mi verrebbe da rispondere a questa domanda dicendo che la medicina contemporanea ha in realtà pochi ricordi e quei pochi solo molto recenti. Funziona anzi piuttosto col meccanismo dell’oblio: perché una nuova pratica, un nuovo approccio, una nuova terapia abbia credibilità, quant’era fatto prima dev’essere cancellato, dimenticato. È la storia dei paradigmi di cui scriveva qualche decennio fa Thomas Kuhn: l’idea di progresso nella scienza e in medicina implica la decadenza e la cancellazione di un paradigma, contestualmente all’instaurazione di uno nuovo. Pertanto, dal punto di vista di chi è implicato nella medicina, la dimensione del ricordo e del passato è sostanzialmente identificato con ciò che non è più, ciò che non si fa più, ciò che non si deve più fare. Si capisce bene che la dimensione storica, in una simile configurazione, rischia per gli attori del mondo della medicina di essere unicamente una suppellettile, un ornamento, o al massimo una narrazione. Essa permette da un lato di intessere una genealogia eroica, punteggiata da figure eminenti che hanno tracciato il cammino della scienza e con cui idealmente identificarsi; dall’altro, di comprovare quanto fallace sia stata la medicina del passato e quanto invece oggi essa sia liberata da errori e pregiudizi, finalmente scienza medica. Il tal modo, per una medicina ottusamente scientista, val la pena serbare il ricordo solo di qualche momento di rottura particolarmente significativo per una narrazione che guarda al passato in funzione degli esiti attuali oppure quello di qualche geniale “precursore” (una nozione letteralmente paradossale, poiché nessuno, per definizione, può vivere fuori dal proprio tempo e contesto) che ha consentito alla medicina di scrollarsi di dosso qualche fardello teorico o pratico ingombrante.
Pertanto la relazione della medicina con la propria tradizione è davvero ambivalente.
Mentre sino al XVI secolo la tradizione costituiva il fondamento di ogni sapere medico e scientifico, essa nei secoli successivi ha assunto nella medicina universitaria dapprima la configurazione di bersaglio polemico dei “neoterici”, poi una connotazione sempre più nettamente negativa sino al punto di essere considerata come sinonimo di arretratezza, fallacia pre-scientifica, addirittura grossolana superstizione. Un riferimento positivo alla tradizione permane, forse, soltanto per alcuni aspetti concernenti la sfera etica, deontologica, comportamentale e genericamente identitaria della professione medica – è caratteristica l’intramontabile referenza al cosiddetto Giuramento d’Ippocrate.
Parlare di memoria, e di storia, in medicina sollecita una riflessione sull’aspetto deontologico, alla luce anche del nuovo codice di deontologia medica (2014) che ripensa la deontologia come una forza viva, che usa una lingua attuale, calata nella storia: quali sono le sue riflessioni su questo legame?
Verrebbe da dire che la deontologia nasce con la nascita della medicina. Sin dalle attestazioni più antiche le pratiche mediche sono per così dire accompagnate da norme e regole di ordine etico e comportamentale, in primis, direi, quello dell’obbligo per il medico di intervenire per curare chiunque gli chieda aiuto, senza alcuna discriminazione. Quest’obbligo della cura, del soccorso, della carità è inscritto a lettere di fuoco nell’ethos del medico. È il fondamento stesso della medicina, verrebbe quasi da dire prima delle stesse abilità tecniche che la contraddistinguono.
Altro elemento che mi pare attraversi una lunghissima cronologia è la nozione che l’accesso alla cura è un diritto di tutti, e la medicina un bene comune. Questa nozione espressa dalle odierne politiche di welfare e da molti sistemi sanitari nazionali è espressa in una delle storie leggendarie che circolavano in età moderna a proposito dell’origine della medicina. Nella Grecia antica, si racconta che i malati che fossero guariti da una qualche malattia lasciassero sempre scritto nel tempio di Asclepio ad Atene tanto la descrizione del male, quanto le tecniche e i rimedi utilizzati per curarlo. Ciò era un uso che aveva una funzione devozionale, di ringraziamento (una sorta di “per grazia ricevuta” ante litteram), ma era anche un modo affinché queste conoscenze fossero di dominio pubblico, disponibili per tutti gli altri malati: chiunque poteva trovare nel tempio risposte utili ed efficaci per i propri bisogni sanitari.
La leggenda vuole che un Asclepiade rubasse tutte le informazioni conservate nel santuario per metterle insieme, ordinandole e organizzandole in un volume. La nascita della medicina, secondo questa leggenda, coincide quindi con l’appropriazione abusiva da parte di un uomo (il medico) di un sapere che di per sé appartiene a tutti. Da qui in poi i medici vivono e operano sul filo del paradosso di una disciplina che appartiene a tutti, che hanno sottratto alla comunità, ma che contribuiscono a verificare, controllare e organizzare.
Oltre a questi, moltissimi sono quegli aspetti di carattere deontologico relativi alla pratica della medicina che hanno radici profondissime e antichissime.
Se oggi sono espressi attraverso dei codici, in particolare dopo Norimberga (1947), in passato queste regole non erano necessariamente scritte e esplicitate. Nondimeno esse erano osservate e applicate, al punto che in molte città europee dei tribunali speciali, istituiti dai collegi medici, avevano proprio il compito di reprimere gli abusi, oltre agli errori, compiuti dai medici.
Inevitabilmente i codici contemporanei regolano comportamenti e relazioni rispetto alle coordinate e agli orizzonti della medicina di oggi con le sue specifiche problematiche e criticità (si pensi alle norme etiche relative ai trapianti) inesistenti nel passato. Tuttavia le radici di tali regole si fondano su saldi principi che appaiono sostanzialmente immutabili nel corso del tempo, come quello di soccorrere, di alleviare la sofferenza, di non arrecare danno al malato, di rispettarlo nella sua dignità di uomo. Naturalmente questi principi sono diversamente declinati attraverso i secoli e i contesti. Gli storici possono forse dare un contributo per riconoscere tali mutamenti, così come per fornire analisi puntuali delle forme complesse assunti dai principi fondamentali che costituiscono la memoria profonda del fare medicina nei diversi contesti temporali, socio-culturali, geografici e politici.
Nella relazione di cura la memoria può spesso “significare” l’altro, ricordarlo: dove sta andando oggi il rapporto di cura, anche rispetto alla tradizione del rapporto medico-paziente oggi molto discusso?
Alla luce di quanto detto prima, ovvero da un lato la memoria corta e la tendenza all’oblio della medicina contemporanea, dall’altro la persistenza profonda in questa stessa medicina di elementi etici e comportamenti ancestrali, la relazione medico-paziente potrebbe essere vista come il banco di prova delle tensioni tra passato e presente. Mi spiego. In un articolo di referenza per noi storici scritto nel 1976, il sociologo Nicholas Jewson ha osservato la progressiva “sparizione del malato” dall’orizzonte della medicina moderna: dalla persona presa a carico dalla medicina umorale, si passa alla parte del corpo affetta della medicina anatomo-clinica, sino alla cellula, focus principale dell’attenzione della medicina contemporanea.
L’articolo mostrava a grandi linee quanto un certo modo di fare medicina, una certa teoria generale che la sostiene, implicasse un approccio specifico al malato, più o meno spersonalizzato. È una tesi che, alla prova minuziosa dei fatti e per singoli casi particolari potrebbe non essere avvalorata, ma come schema interpretativo generale mi pare abbia una fortissima pregnanza. È vero che nella medicina contemporanea – lo denunciava anche Karl Jaspers qualche decennio or sono – si rischia l’azzeramento dell’entità personale del paziente, la sua molecolarizzazione, l’oggettivazione nuda e cruda della malattia al netto del soggetto malato. Tuttavia le radici etiche ancestrali del fare medicina impongono, silenziosamente, un’attenzione alla persona, al singolo soggetto in cui una certa malattia si annida e a cui un certa terapia si applica. Il paziente, se dotato di coscienza critica, è lì per ricordarlo al suo interlocutore medico o all’istituzione di cura.
Gli storici, i sociologi, gli antropologi, i filosofi sono anche lì per allertare o risvegliare la coscienza sopita di medici e pazienti proprio sui rischi che si annidano nella disumanizzazione del rapporto terapeutico, per risvegliare, quando necessario, la memoria etica profonda del fare medicina. Per questo ormai nella maggior parte delle facoltà di medicina, si dà spazio all’insegnamento della storia e delle scienze umane. A Ginevra, dove io insegno, praticamente per ogni unità di studio, soprattutto nei primi tre anni, sono previsti insegnamenti in scienze umane. Non disponiamo ancora di studi sull’impatto di tale formazione nella pratica della medicina, ma di certo gli studenti la apprezzano e all’ospedale di Ginevra si sviluppano progetti che valutano la qualità dell’accoglienza e della cura anche sul piano della relazione umana tra medico e paziente e del suo impatto sul processo di guarigione.
Autore: Redazione