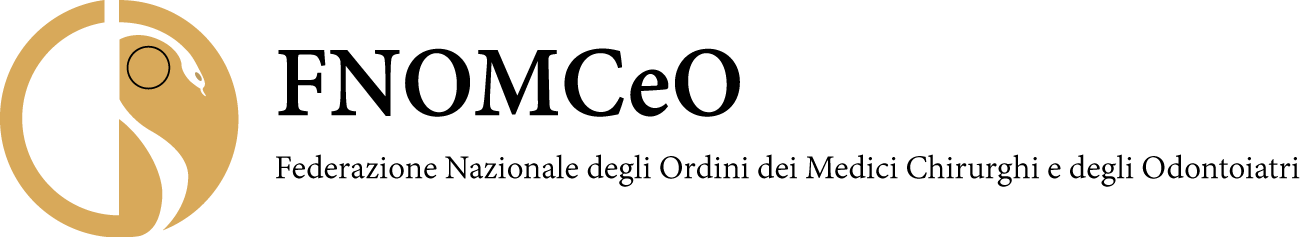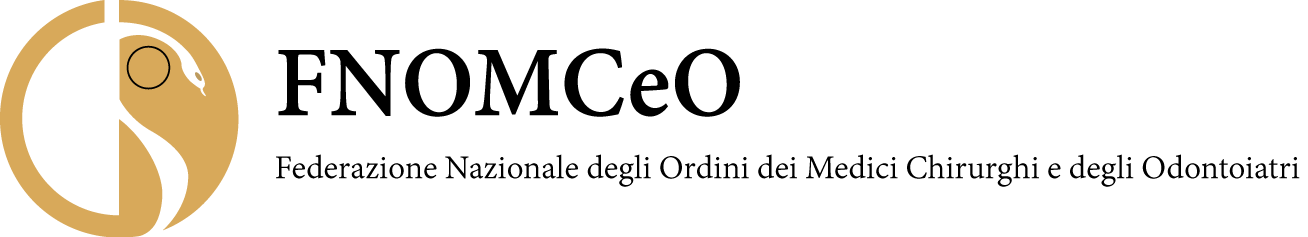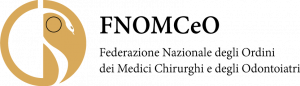Pillole per guarire dal cancro o dall’epatite C, ma anche per essere sempre efficienti e al massimo delle potenzialità; pillole per risolvere ogni problema, pillole che, per il loro costo elevatissimo, diventano esse stesse un problema per pazienti e interi Sistemi sanitari che non possono permettersele; pillole disegnate, studiate, fabbricate, pubblicizzate, vendute secondo le più abili strategie di marketing, che arrivano a creare nuove malattie per poi ‘piazzare’ la cura.
È dedicato al mondo del farmaco, dell’industria farmaceutica e alle sue ‘relazioni pericolose’ con istituzioni, medici, ricercatori, società scientifiche, associazioni di pazienti, informatori, giornalisti, il nuovo libro di Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici di Torino e componente del Comitato Centrale Fnomceo (anche se in premessa si chiarisce che le opinioni da lui espresse ‘sono personali e non riflettono necessariamente quelle dell’istituzione che rappresenta’), scritto a quattro mani con la giornalista di Repubblica Sara Strippoli e pubblicato da Add editore. Emblematico il titolo: “Pillole”, appunto.
“Pillole vuole provare a raccontare Big Pharma, termine in sé neutro che indica le industrie farmaceutiche con miliardi di ricavi, ma che da un po’ di tempo ha assunto una connotazione negativa per i tanti scandali che hanno toccato il settore” si legge nell’introduzione.
“E per raccontare vizi ed errori, tattiche promozionali, dimenticanze fatali nella comunicazione degli effetti collaterali e politiche di marketing aggressive – continuano i due autori – , siamo andati virtualmente in giro per il mondo a cercare storie emerse dagli articoli delle più autorevoli riviste di medicina che, di qua e di là dell’Oceano, hanno tentato di fare una fotografia di ciò che è accaduto e sta per accadere nell’universo del farmaco”.
Ecco allora che Giustetto e Strippoli ci accompagnano a scoprire come nasce un farmaco, anzi prima, ci lasciano assistere al suo concepimento e alle strategie pre-marketing. Ci fanno vedere i suoi primi passi, la sperimentazione clinica, sino all’immissione in commercio, alle tecniche di promozione più o meno trasparenti. Ci rendono compagni dei pazienti nei loro ‘viaggi della speranza’ per acquistare all’estero farmaci troppo costosi; ci forniscono gli strumenti per smascherare Wakefield nella truffa ordita per inventare una falsa relazione tra vaccini e autismo; ci inducono a chiederci come sia stato possibile che il Vioxx sia rimasto per anni in commercio nonostante la consapevolezza sui suoi effetti collaterali anche gravi, tanto che, come testimoniò David Graham, direttore associato del dipartimento di sicurezza dei farmaci della Fda di fronte all’apposita commissione senatoriale l’11 novembre 2014 “Gli eventi cardiaci gravi legati al Vioxx dal 1999 al 2004 si stimano fra 88.000 e 140.000…come se fossero caduti 4-500 aerei di linea».
Un libro che si legge d’un fiato, “Pillole”,come un romanzo ‘giallo’ ma i cui fatti sono documentati da prove schiaccianti, tutte riportate nella corposa bibliografia finale.
“Non è stato difficile – concludono gli autori – ricostruire le nostre storie sulla base degli articoli delle principali riviste mediche, «Bmj», «Jama», «Nejm», «The Lancet», «Plos medicine» e delle inchieste delle grandi testate generaliste, dal «New York Times» al «Guardian», che hanno affrontato gli aspetti meno limpidi dell’industria farmaceutica. Gli approfondimenti che sono emersi dalle inchieste, oltre a confermare l’integrità di gran parte del mondo culturale medico, si sono anche dimostrati una ricchezza per tutti e una fortuna per i medici, la maggioranza, che non si lasciano distogliere dalla loro missione primaria che resta sempre la salute dei pazienti”.
Ma perché un libro del genere in questo particolare momento storico? A circa un mese dall’uscita, siamo andati ad approfondire l’argomento con Guido Giustetto.
Pillole, ma anche anticorpi monoclonali, per non parlare dei vaccini: sempre più si assiste a una frattura, a una polarizzazione per cui, da una parte, si assiste a un neo positivismo e la scienza, la medicina sono idolatrate e sembrano la soluzione a ogni malessere; dall’altra, la gente ha sempre meno fiducia nelle istituzioni. Dottore, che cosa è successo?
È venuto meno quel patto informale che è sempre esistito tra medici e industria farmaceutica, secondo il quale l’industria fornisce ai medici prodotti efficaci per la cura e la prevenzione, ricevendo in cambio il giusto guadagno. E quando si è rotto questo equilibrio? Abbiamo una data: era infatti il 1976 quando Henry Gadsen, allora direttore della casa farmaceutica Merck, dichiarò alla rivista «Fortune»: «Il nostro sogno è produrre medicine per le persone sane. Questo ci permetterebbe di vendere a chiunque». A distanza di più di 30 anni, il suo auspicio sembra essersi realizzato perché, in tutto questo tempo, ci hanno abituato a pensare che una pillola possa risolvere ogni problema.
E quali sono le principali strategie che l’industria farmaceutica mette in atto per allargare a dismisura il mercato delle sue ‘pillole’?
La prima, la più conosciuta, e forse anche la più facilmente smascherabile è il cosiddetto disease mongering, il commercio di malattie. In altre parole, non si vendono semplicemente le cure per una patologia ma, individuata una medicina, si crea la malattia da curare. O, meglio, si ‘medicalizzano’ disturbi che per qualcuno sono significativi ma che, per la gran parte della popolazione, sarebbero perfettamente compatibili con le normali condizioni di vita.
È una strategia conosciutissima del marketing, quella di creare il bisogno per vendere il prodotto. Ma come si applica alla salute?
Le faccio alcuni esempi: la sindrome delle gambe senza riposo. Per qualcuno, è vero, si tratta di un problema serio. Ma se lo si eleva al rango di disturbo, di malattia, pubblicizzandone i sintomi e organizzando magari campagne ‘di prevenzione’, cresceranno le diagnosi e si allargherà di conseguenza il mercato per i farmaci. Lo stesso per la timidezza: capisco che possa mettere a disagio qualche persona, ma da qui a definirla disturbo psichiatrico ce ne corre. Nel 1917 l’Associazione psichiatrica americana aveva catalogato 59 disturbi psichiatrici. Nel 1952, con l’introduzione del Manuale diagnostico e statistico dei disordini mentali (il famoso Dsm), ritenuto la Bibbia della psichiatria, i disordini certificati erano saliti a 128. Nel 1968 erano 159, 227 nel 1980 e 283 nel 1987. Adesso sono 347. Compresa la timidezza, etichettata come fobia sociale.
Ma, leggendo il libro, si capisce che esistono anche strategie più sottili di questa …
Sì, un’altra linea d’azione è prendere patologie importanti, come l’ipertensione, il diabete, le dislipidemie, e convincere la comunità scientifica ad abbassare le soglie di rischio, argomentando che tanto più precoce è la diagnosi, tanto più efficace sarà la terapia. Ma è sempre così? Consideriamo le linee guida per l’ipertensione: fino ad alcuni anni fa il paziente si considerava iperteso, e quindi da curare, se la pressione superava i valori di 140 e 90 mm di Mercurio. Nel 2003 si abbassarono i valori ottimali a 120 per la massima, 80 per la minima, introducendo la fascia della pre-ipertensione. Ma è realmente vantaggioso intervenire con i farmaci anche in questa fascia? Le evidenze dicono di no. Anzi, in certe classi di età o in caso di comorbilità abbassare troppo la pressione provoca più svantaggi che benefici. L’organizzazione internazionale Cochrane (un ente no-profit punto di riferimento per una corretta informazione nell’ambito della salute) ha realizzato sul tema due studi secondi i quali mirare a un obiettivo inferiore a 140/90 mmHg non è vantaggioso neppure nel caso dei pazienti ipertesi diabetici. Per loro, al contrario, l’abbassamento della pressione sotto i 140/90 mmHg porta a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare. I farmaci antipertensivi utilizzati nel trattamento dell’ipertensione lieve, inoltre, non hanno affatto dimostrato di riuscire ad abbassare la mortalità. Ma andiamo anche oltre queste strategie, andiamo anche alla fonte: la sperimentazione sui farmaci.
Sta forse suggerendo che può esserci un problema di integrità della ricerca scientifica?
Non sono io a dirlo: la valutazione degli esperti è che metà della letteratura scientifica sia falsa.
“La scienza – scrive nel 2015 l’ex direttore di «The Lancet» Richard Horton – sta andando verso l’oscurità”. La sua analisi è spietata: gli scienziati troppo spesso forgiano i dati per avvalorare una tesi precostituita. Oppure rivedono le ipotesi per adattarle ai dati. Anche le riviste meritano la loro parte di critica, mentre le università s”ono in una lotta costante alla ricerca di soldi e talenti”. John P.A. Joannidis, docente di politiche sanitarie e direttore del Centro prevenzione e ricerca all’Università di Stanford, ha pubblicato nel 2015 su “Plos Medicine” un articolo dal titolo emblematico: “Perché la maggior parte della ricerca è falsa”. Ancor più chiare le conclusioni: adottando una serie di criteri indice della veridicità di uno studio, “le simulazioni dimostrano che per la maggioranza degli studi è assai più probabile che una ricerca sia falsa piuttosto che veritiera”.
Ma come si può manipolare uno studio scientifico, che, per sua natura, dovrebbe essere quanto di più rigoroso possibile?
Dipende innanzitutto da come si costruisce il disegno dello studio. I farmaci si testano contro un placebo, che non ha effetti farmacologici o, soprattutto nel caso di patologie che non sarebbe etico lasciare senza una cura, confrontandoli con un farmaco già approvato. Ed ecco il trucco: confrontando il nuovo farmaco non con quello di riferimento ma con un medicinale inadeguato, perché poco efficace o con gravi effetti collaterali, anche un minimo miglioramento terapeutico sarà accolto come un grande beneficio. Oppure il farmaco di confronto sarà sotto dosato, o somministrato per una via attraverso cui l’assorbimento è minore. Altro trucco, usato invece negli studi che cercano di minimizzare gli effetti collaterali, è testare il nuovo farmaco a dosaggio basso contro il vecchio a dosaggio terapeutico. Tanto, in questa fase preliminare non andrò a indagare i benefici, ma solo gli eventuali effetti avversi.
In altri casi il numero di pazienti su cui è condotta la ricerca non è sufficiente per trarre conclusioni sicure. In altri ancora, le caratteristiche delle persone che compongono il campione non sono rappresentative dei pazienti reali curati tutti i giorni dal medico di famiglia o in ospedale. Non sorprende quindi che, come riportate nel libro, da un’indagine condotta nel Regno Unito, emerga come l’80 per cento dei medici e il 60% dei pazienti non abbia fiducia nei risultati delle ricerche finanziate dall’industria farmaceutica. È inutile nasconderselo: la maggior parte della ricerca è finanziata dall’industria farmaceutica. È quindi proprio l’industria a doversi assumersi la responsabilità degli studi che mette in piedi e a dover ricostituire questo rapporto di fiducia. Iniziando proprio da una maggior trasparenza: anche senza arrivare a questi estremi di manipolazione dei dati, non possiamo non considerare il bias che si crea a causa di una pratica questa sì piuttosto diffusa, quella di non pubblicare gli studi con risultato negativo. Quando, magari come passo propedeutico alla stesura di linee guida, tutti gli studi analoghi verranno presi in considerazione per una metanalisi, mancheranno quelli con esito negativo e i risultati saranno di conseguenza falsati.
Ma almeno su questo ci sono margini di intervento?
Certo: basterebbe istituire un registro pubblico sul quale ciascun ente che iniziasse una ricerca fosse obbligato a pubblicare la data di inizio, i metodi, gli obiettivi e, alla fine, gli esiti.
Un’altra cosa: sarebbe fondamentale che ciascun ricercatore potesse accedere ai dati originali e agli studi integrali, non agli abstract a volte “addomesticati” usati per la comunicazione. Prendiamo il caso dell’oseltamivir, un antivirale che era stato ‘lanciato’ in occasione dell’aviaria e poi della suina, e pubblicizzato come efficace contro tutti i virus dell’influenza, in grado di accorciare la durata della malattia e ridurre i ricoveri. Per anni la ditta produttrice ha bloccato l’accesso ai dati originali. Quando nel 2014 li ha desecretati, la ‘sorpresa’: in effetti i dati dimostravano un accorciamento della sintomatologia, ma di solo mezza giornata.
E qui si riapre la questione della trasparenza … trasparenza non solo dei risultati, ma dei rapporti e dei flussi di denaro.
È legittimo che ci siano rapporti anche tra i medici e l’industria: l’importante è sapere chi collabora con chi e su quale argomento.
Il 30 giugno 2016 anche in Italia ha preso il via il Disclosure Code, che impegna le aziende a pubblicare sui propri siti web, anno per anno, tutti i rapporti economici con i medici e le loro organizzazioni.
Circa il 70 % dei medici italiani hanno dato il consenso. Alcune case farmaceutiche, una per tutte la Glaxo, non istituiscono rapporti economici con i medici che si rifiutano di fornire il consenso. Tutto bene dunque? Sì, ma si potrebbe fare di più. Ora come ora, per sapere se un medico intrattiene rapporti finanziari con l’industria farmaceutica, dobbiamo andare a vedere uno per uno i siti di tutte le aziende italiane, che tra l’altro pubblicano i dati in maniera diversa, e poi sommare i diversi flussi. Sarebbe invece più utile avere, come avviene già del resto negli Stati Uniti, un unico sito, magari facente capo al Ministero della Salute, per cui, per ogni medico o associazione, si vedano i rapporti con le diverse aziende, magari spiegando a che titolo i finanziamenti sono erogati.
Ma i medici che non sono direttamente coinvolti nella ricerca o nelle consulenze, parlo dei clinici, medici di famiglia, specialisti, ospedalieri, hanno consapevolezza dell’influenza dell’industria? E come possono difendersi?
In qualche modo verosimilmente sì ma non completa: siamo anche noi persone umane, influenzabili dalla promozione farmaceutica così come dalla pubblicità. Possono aiutarci gli studi sulle tecniche promozionali: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scritto un manuale, destinato agli studenti di Medicina, per insegnare a fronteggiare le promozioni delle case farmaceutiche e capire quando e quanto l’informazione che ricevono è sponsorizzata.
Un altro modo per acquisire consapevolezza è informarsi attraverso riviste indipendenti: in Italia ce ne sono di serie e diffuse, alcune indipendenti anche dal Ministero. Penso a «Informazioni sui farmaci», «Infofarma», «Ricerca&Pratica», per citarne solo alcune. Come scrivo nelle conclusioni, “Più informazione significa meno reazioni pericolose”.
E i pazienti? Come potranno, dopo aver letto il libro, non guardare con un occhio di sospetto le ‘pillole’ che il medico prescrive loro?
Una volta si diceva, scherzando ma non troppo, di lanciare, entrati nell’ambulatorio, un’occhiata al lettino: se era ingombro di campioni di medicinali, era segno che il medico in questione privilegiava il rapporto con gli informatori a quello con i pazienti. Oggi certi estremi per fortuna non esistono più, ma, d’altro canto, le tecniche di marketing sono diventate più subdole e sofisticate. L’unico scudo, oggi come allora, è l’alleanza terapeutica, quella relazione di fiducia che non si costruisce in un giorno. Solo fidandosi e affidandosi al proprio medico, infatti, si può avere la certezza che la terapia scelta è la migliore possibile per il paziente e per la malattia.
Autore: Redazione FNOMCeO