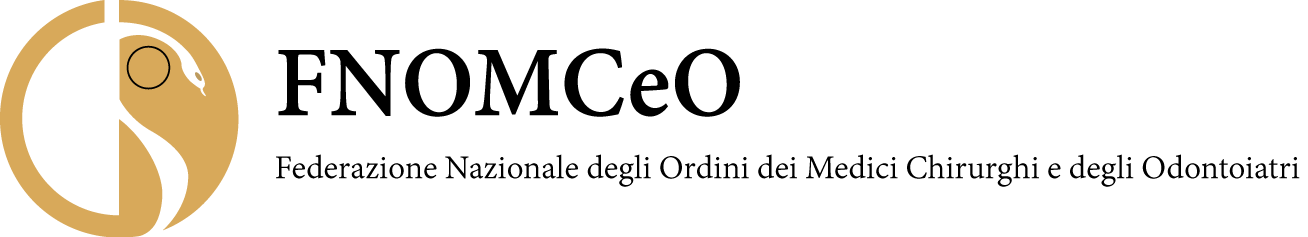In occasione della Convenzione di Istanbul recentemente ratificata dal Parlamento Italiano, anche la FNOMCeO, tramite il Presidente Bianco e il lavoro dell’Osservatorio donne della Federazione, ribadisce la necessità di una partecipazione attiva della classe medica per combattere le violenze e gli abusi sui minori e sulle donne.
In occasione della Convenzione di Istanbul recentemente ratificata dal Parlamento Italiano, anche la FNOMCeO, tramite il Presidente Bianco e il lavoro dell’Osservatorio donne della Federazione, ribadisce la necessità di una partecipazione attiva della classe medica per combattere le violenze e gli abusi sui minori e sulle donne.
Quotidianamente i media riportano notizie di violenze e di “femminicidi” fenomeno estremo di un problema molto più ampio e occuparsi di questi problemi e di come fare ad affrontarli non è più procrastinabile.
Cos’è la violenza, come si manifesta, chi è interessato dal problema non ha una risposta unica. Le forme di violenza sono molteplici, si manifestano in molti modi, in diversi contesti, familiari, lavorativi, occasionali, hanno molte cause e concause e dunque anche le soluzioni non possono che essere complesse. Ma le risposte sociali a questo fenomeno sono ancora frammentarie e insufficienti.
I medici di Medicina generale, di Pronto Soccorso, Ginecologi, Pediatri, ma anche odontoiatri sono spesso i primi che possono intercettare i problemi e dunque devono essere in grado riconoscerli e affrontarli adeguatamente. E’ importante che le donne e i minori trovino accoglienza in un ampia rete sociale, servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, magistratura, enti locali, centri antiviolenza, associazioni, attraverso protocolli e procedure coordinate e condivise.
Questo lavoro a Sassari, promosso dall’Ordine dei Medici e dall’Ordine degli Avvocati, coordinato dalla Prefettura di Sassari, è già iniziato e il 3 luglio scorso è stato presentato, dalla Rete dei librai e la Rete delle Associazioni delle donne di Sassari, il libro della professoressa Patrizia Romito e del professor Mauro Melato intitolato "La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo".
Nell’occasione, abbiamo intervistato la professoressa Romito, uno dei due autori del volume.
Prof.ssa Romito, si parla molto in questo periodo di violenza e abusi sulle donne e la cronaca riporta notizie di donne uccise ogni tre giorni. Lei ha studiato a fondo questo problema, è un fenomeno in aumento?
Secondo i dati dell’Istat, relativi al 2006, il 14% delle donne italiane ha subito violenze fisiche o sessuali da un partner nel corso della vita; le violenze psicologiche sono molto più frequenti, e sappiamo che possono essere altrettanto devastanti per le donne che le subiscono. Negli ultimi mesi, i giornali riportano quasi ogni giorno la notizia di una donna o ragazza uccisa dal partner. Non possiamo sapere tuttavia se queste violenze siano diventate più frequenti negli ultimi anni, perché non abbiamo dati attendibili in proposito: anche per quanto riguarda le donne uccise, ci si basa soprattutto sulle notizie riportate dai giornali. Uno studio condotto da una mia studentessa alcuni anni fa, analizzando gli articoli relativi a questi casi pubblicati sul Corriere della Sera, indicava che negli anni ’60 – e cioè prima dell’introduzione di leggi come il nuovo diritto di famiglia, l’abolizione del delitto d’onore, la liberalizzazione della contraccezione e la legge sull’aborto- questi delitti erano più numerosi; negli anni ’60, gli uomini tendevano ad uccidere le mogli, mentre oggi uccidono le “ex” mogli o fidanzate, le donne che vogliono lasciarli, o li hanno appena lasciati. Che siano più o meno numerosi di alcuni decenni fa, maltrattamenti, abusi e uccisioni sono oggi spaventosamente frequenti, una vera ecatombe.
Nell’introduzione del suo libro lei sostiene che la violenza occorre "vederla". Cosa intende, è così anche per i medici?
La violenza contro le donne è oggi molto più visibile di alcuni anni fa: è più probabile che le vittime ne parlino e cerchino aiuto; i giornali danno spazio a queste notizie, anche se non sempre le riportano e le commentano correttamente. Tuttavia, “vedere” davvero la violenza significherebbe prendere sul serio le donne quando ne parlano, credere loro e prendere le necessarie misure. In molti casi di femminicidio, i giornali ci dicono che queste donne avevano denunciato l’uomo, avevano cercato aiuto, si erano opposte al fatto che lui potesse vedere e tenere con sé i bambini. Non sono state credute, o comunque le loro domande di aiuto sono rimaste inascoltate, finchè l’uomo non le ha uccise. Solo per citare due casi recenti (luglio 2013), ricordiamo Rosy Bonanno, uccisa a Palermo dopo aver fatto almeno 6 denunce contro l’ex partner, o i due fratellini, avvelenati e bruciati in Valcamonica dal padre, che continuava a minacciare e aggredire l’ex moglie dopo la separazione. In entrambi i casi nessuno ha preso sul serio anni di violenze, peraltro note: basti pensare che entrambi questi uomini avevano diritto a vedere regolarmente i figli. In questo senso, sostengo che occorre vedere la violenza, cosa che finora non avviene sistematicamente.
Per quanto riguarda i medici, finora si sono comportati come la maggior parte delle altre persone: non hanno saputo o voluto vedere. In uno studio svolto alcuni anni fa a Bologna, la maggior parte degli operatori intervistati affermò di non aver mai incontrato donne vittime di violenza domestica nel corso della propria attività professionale, quando negli stessi anni, dal 1990 al 1996, ben 1.854 donne si erano rivolte alla “Casa delle donne per non subire violenza” della stessa città. Più recentemente, in una ricerca su 190 medici di medicina generale (MMG) condotta in collaborazione con la Federazione italiana dei MMG (Alinari et al., 2003), ben il 34% degli intervistati risponde che non ha mai avuto la sensazione di avere di fronte pazienti vittime di violenza domestica. Per contrasto, in uno studio su un campione di donne pazienti di MMG, il 10% aveva subito nell’ultimo anno maltrattamenti fisici e il 17% abusi psicologici, in entrambi i casi da un partner. In passato, ben il 39% aveva subito violenze fisiche, da un partner o da un familiare (Cumin, 2014). Da notare che nello stesso studio, il 79% delle donne riteneva giusto che il medico facesse una domanda sulla violenza a tutte le pazienti! Per i medici il problema è duplice: devono avere gli strumenti prima per vedere la violenza, poi per considerarla come un fenomeno di cui devono occuparsi come medici.
Come possono i medici contribuire ad affrontare questo problema che possiamo definire di salute pubblica?
Già nel 1997, un documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affermava che “la violenza contro le donne rappresenta un problema di salute enorme … A livello mondiale si stima che la violenza sia una causa di morte o di invalidità per le donne in età riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute più importante degli effetti degli incidenti del traffico e della malaria combinati insieme”.
E’ quindi necessario che i medici, così come gli altri operatori sanitari e sociali, riconoscano che la violenza c’è e si diano i mezzi per vederla e per intervenire in modo appropriato: che si formino sulla frequenza, sulle caratteristiche e sull’impatto della violenza sulla salute delle vittime, sugli obblighi di legge, e sulla maniera migliore di rapportarsi a una donna che è, o potrebbe, essere vittima di violenza. E’ inoltre fondamentale che il medico faccia parte della rete di operatori e servizi che sono implicati nella risposta alle vittime di violenza: centri anti-violenza, se ne esistono sul territorio, forze dell’ordine, magistrati, servizi sociali… Il medico ha un ruolo importantissimo da giocare, sia perché è spesso la prima persona a cui una donna dice o lascia intendere una storia di violenza, sia perché gli/le è riconosciuta grande autorevolezza a livello sociale. Tuttavia, non può fare tutto: deve assumersi la sua parte e poi essere in grado di indirizzare la donna a quei servizi che possono accompagnarla nel percorso di uscita dalla violenza.
Lei parla di approccio di rete e nel suo libro analizza le best practices e i vari protocolli inter istituzionali per affrontare il problema. I medici devono farne parte?
Certamente, come ho detto prima, è essenziale che i medici facciano parte della Rete territoriale, sia per non doversi far carico anche dei bisogni delle vittime che non sono di loro competenza, sia perché nessun operatore singolarmente è in grado di rispondere a tutti questi bisogni. E’ tramite l’attività di rete e coordinamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio, che è possibile fornire sicurezza, protezione e aiuto alle donne e ottimizzare e coordinare il percorso di uscita dalla violenza. Anche se ci sono delle specialità mediche particolarmente coinvolte – medici di Pronto Soccorso, ginecologi, psichiatri, MMG- tutti i medici dovrebbero essere consapevoli della violenza e capaci di intervenire, perché la violenza può avere effetti devastanti su tutti gli organi e le funzioni. Nel nostro manuale, abbiamo chiesto di intervenire anche a un dentista, proprio per sottolineare la necessità che tutti i medici siano attenti al fenomeno.
E’ necessaria una conoscenza e una formazione specifica per riconoscere e affrontare adeguatamente il problema. Lei tiene presso l’Università di Trieste un corso monografico sulla Violenza di genere.
I medici, come gli altri professionisti coinvolti nella riposta alle vittime di violenza – poliziotti, magistrati, psicologi, assistenti sociali…- devono essere formati fin dai primi anni di Università a riconoscere la violenza e a rispondere in maniera appropriata. Dal 2003, tengo un corso di 15 ore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste su “Violenza alle donne e ai minori”, per gli studenti del primo anno. Il corso è facoltativo, con un esame finale: la grande maggioranza degli studenti iscritti lo segue e si appassiona alla questione, che, in molti casi, oltre che come futuri professionisti, li tocca direttamente, perchè possono aver assistito a maltrattamenti domestiche o possono aver subito, specialmente le ragazze, molestie o violenze. Al corso intervengono sempre le operatrici del Centro Anti-violenza di Trieste e alcuni professionisti impegnati e competenti sul tema della violenza: MMG, pediatra, ginecologa, assistente sociale nonché un comandante dei carabinieri.
E’ chiaramente essenziale che una prima formazione generale avvenga fin dai primi anni di Università e che sia ripresa negli ultimi anni, nel contesto di corsi più specifici, senza dimenticare la formazione dei medici (e degli altri operatori sanitari: infermieri, terapisti della riabilitazione..) che già operano. Questi professionisti spesso non sono preparati ad affrontare i casi di violenza nelle pazienti: ciò contribuisce a renderli meno “recettivi” e a creare ansia, perché non sanno cosa fare. Di conseguenza, preferiscono non vedere, o quando vedono si sentono sovraccaricati da un eccessivo coinvolgimento che non sono preparati a gestire. In questo senso li può aiutare molto conoscere le risorse del territorio, in primis eventuali Centri antiviolenza locali ed essere consapevoli di quali risorse le donne possono trovare nei Centri.
Gli Ordini dei Medici devono farsi carico di questo problema e promuovere iniziative atte ad affrontare e prevenire questo problema?
(a questa domanda risponde la dott.ssa Margherita De Marchi, MMG dell’ULSS n.1, Belluno, che ha fondato il Centro Anti-violenza di Belluno e ha contribuito con un capitolo alla “Guida”)
Gli Ordini dei Medici potrebbero fare molto nell’ambito della formazione e sensibilizzazione, veicolando il messaggio che occuparsi di violenza di genere nella quotidianità della propria professione è normale e doveroso, tanto come occuparsi di ipertensione arteriosa o di diabete; potrebbero inoltre fare pressione sulle istituzioni perché la formazione degli operatori sanitari sulla violenza di genere diventi una prassi, anche a livello di studi di base.
Non dimentichiamo infine che la formazione può avere un’ulteriore finalità: infatti, come in tutte le categorie, anche nell’ambito medico ci sono professioniste che sono/sono state vittime di violenza. La formazione può contribuire ad offrire alcuni strumenti utili per elaborare un vissuto che rischia, in alcuni casi, di rendere più complesso l’approccio alla paziente vittima di violenza.
Autore: Redazione FNOMCeO