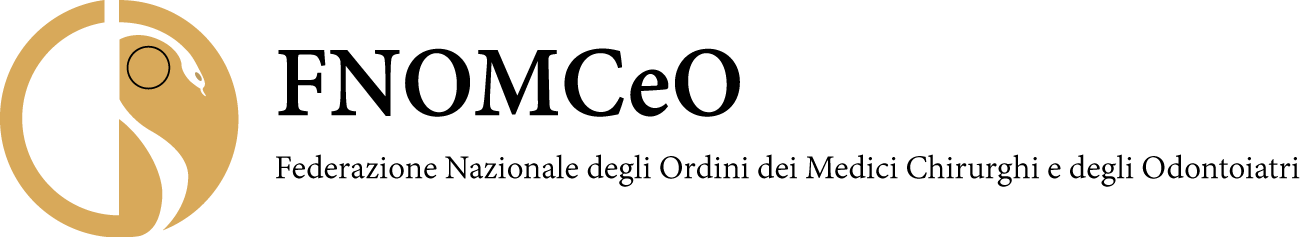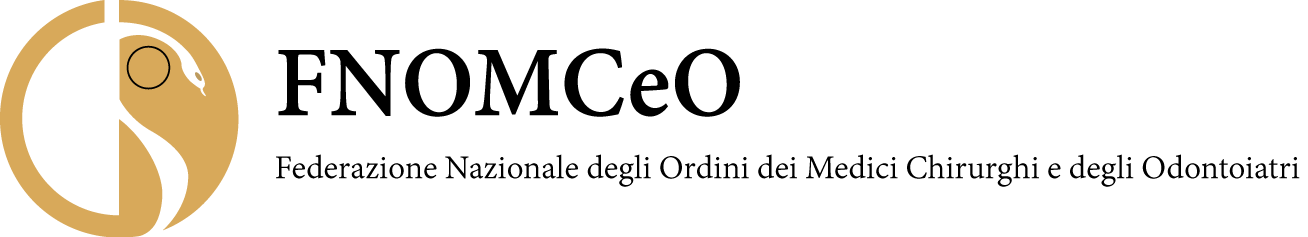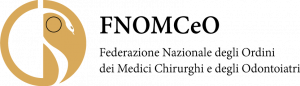Sulle criticità della ricerca scientifica in ambito nutrizionale e le distorsioni cui spesso viene sottoposta nel processo di essere divulgata si è detto più volte: come ricordava l’articolo di apertura del focus dedicato all’alimentazione (a p. 15 del primo numero di «Torino Medica» pubblicato quest’anno: vedi), uno dei problemi di questo settore della ricerca è l’alta percentuale di studi osservazionali le cui conclusioni, anche quando non siano confermate da ulteriori strumenti di verifica (per esempio da trial controllati randomizzati), tendono a essere presentate come “dati di fatto”. Quando all’approccio ‘sensazionalistico’ di tanta stampa si aggiungono a monte “difetti metodologici, pregiudizi e conflitti di interesse”, fare chiarezza diventa un compito non facile. Ed è proprio a proposito dei conflitti di interesse che intervengono due ricercatori della Stanford University in un articolo di opinione pubblicato su Jama a inizio dicembre (vedi).
L’ambito della nutrizione, sostengono John P. A. Ioannidis e John Trepanovski, è uno dei campi più controversi della ricerca scientifica. Passate in rassegna le ragioni per cui ciò accade (dalla difficoltà a isolare gli effetti di un singolo cibo o nutriente sullo stato di salute complessiva della popolazione all’eccesso di studi osservazionali, dai quali appunto “è notoriamente difficile trarre inferenze causali”), l’articolo ricorda l’‘effetto domino’ che tali premesse tendono fatalmente a innescare: “Quando i dati non sono chiari, opinioni e conflitti di interesse, finanziari e non, possono influenzare studi, editoriali, linee guida e, in ultimo, leggi”. L’appello degli autori, quindi, è di rivedere le norme che riguardano le dichiarazioni di conflitto di interesse (conflict of interest disclosures), ritenute al momento non garanti di trasparenza. A questo fine vengono descritti tutti i potenziali conflitti e i relativi bias.
Il primo caso è per quello per antonomasia: l’interesse di tipo economico, sotto l’ombra lunga dell’industria alimentare e delle sue lobby. A proposito dell’annoso intreccio tra ricerca e industria, l’articolo da una parte raccomanda un approccio equilibrato (“la visione puritana secondo cui accettare finanziamenti dall’industria alimentare costituisca, ipso facto, un bias che inficia automaticamente i risultati è datata”), dall’altra sollecita l’istituzione di un registro appositamente dedicato alle dichiarazioni di interesse economico: per limitare le ingerenze dell’industria e per comprendere meglio “come possano esserne influenzate la letteratura scientifica, la politica e le preferenze alimentari dei singoli individui e della collettività”.
A seguire, l’indicazione di una serie progressivamente meno ovvia di “potenziali inquinanti”. Per esempio le rendite finanziarie indirette, come quelle che derivano dai libri su alimentazione, diete e stili di vita rivolti ‘a tutti’: “Dato l’interesse che l’argomento riscuote nel grande pubblico, spesso questi libri sono dei best-seller anche nel caso in cui, a fronte di slogan accattivanti, non offrono solide evidenze a supporto dei contenuti”. Anche le iniziative no-profit, se richiedono grossi finanziamenti per non chiudere in rosso, possono nascondere qualche ombra. In questo comparto occorrerebbe poi valutare il ruolo (cruciale) della comunicazione, perché la visibilità di un articolo scientifico attraverso la sintesi che ne danno i comunicati stampa e il passaggio su giornali, tv, social media ecc. ha un grosso peso nell’acquisizione collettiva dei contenuti che veicola.
Esistono poi conflitti di interesse che non hanno a che fare con il profitto. Gli autori li individuano nei “bias legati alla lealtà, o semplicemente, alla preferenza nei confronti di alcune teorie piuttosto che altre”. Nessun ambito di ricerca, e nessun ricercatore, ne è del tutto immune, ma secondo gli autori l’ambito in questione sarebbe più insidioso anche da questo punto di vista: considerando la nutrizione come la summa non soltanto delle conoscenze teoriche acquisite nel corso della formazione ma delle esperienze culturali ed esistenziali interiorizzate da ciascun individuo, il rischio di condizionamento è ritenuto più elevato e al tempo stesso più subdolo (un autore che sia religioso osservante, si chiedono Ioannidis e Trepanovski, sarà in grado di ammettere che un’abitudine alimentare prevista dal proprio credo non è sana, e quindi di proporre di non osservarla?).
Anche le attività di advocacy (gli orientamenti, le scelte e gli stili di vita che ne derivano) pongono lo stesso problema. Se l’attivismo è un legittimo strumento di sollecitazione al cambiamento socio-culturale, politico, ecc. e può apportare “importanti contributi nell’ambito della salute pubblica”, rispetto alla neutralità della ricerca e al distacco oggettivo che è prerogativa del metodo scientifico sarebbe invece un ostacolo. Si parla in questo caso di white-hat bias, cioè di bias che distorcono l’evidenza scientifica a supporto di un obiettivo percepito come giusto e necessario al miglioramento della salute. (Qui uno studio in open access che si sofferma su questo tipo di bias in relazione all’obesità).
Nell’ambito delle preferenze alimentari, se un articolo scientifico (e a maggior ragione la recensione di un testo o un articolo di opinione) riguardano dieta vegana, dieta di Atkins, senza glutine, a base di proteine animali ecc., e gli autori ne sono seguaci, dovrebbero dichiararlo.
A fronte di tutte le pressioni e criticità elencate, le conclusioni di Ioannidis e Trepanovski si possono riassumere in una sola indicazione: mettere tutte le carte in chiaro. Sapere “chi sta promuovendo che cosa e perché” consentirebbe una lettura dei dati meno opaca, contribuendo a ridurre almeno un po’ la confusione corrente.
Di Sara Boggio
www.torinomedica.com
Autore: Redazione FNOMCeO