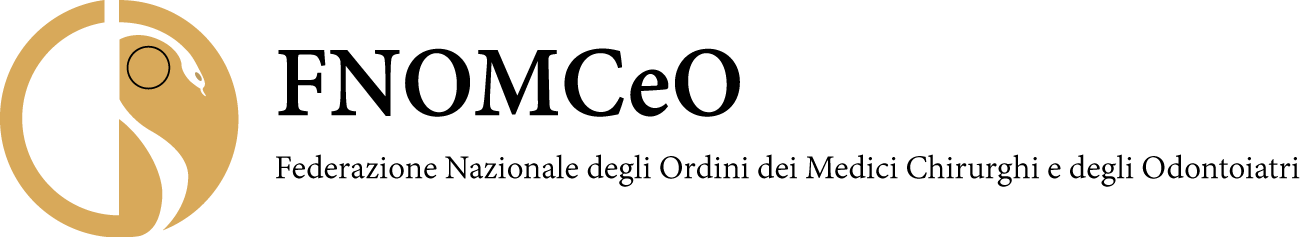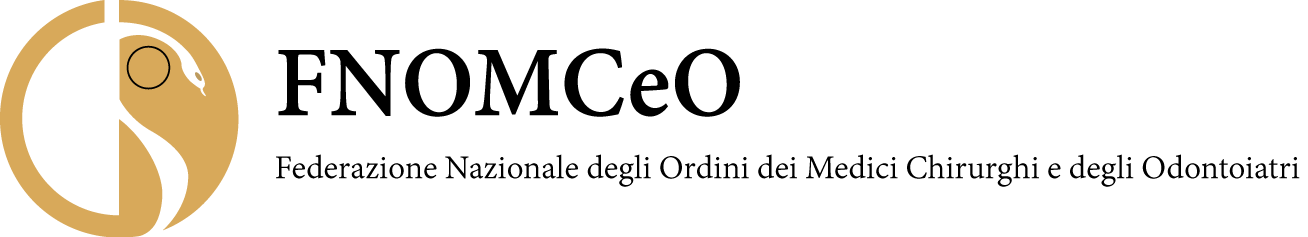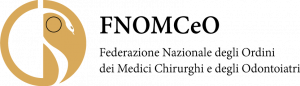Un medico
buono o un buon medico?
Una prima accezione dell’umanizzazione di
cui si sente il bisogno in medicina riguarda l’ “umanità”, intesa come sintesi
di qualità morali richieste a coloro che praticano attività di cura. Un
episodio, tratto dal resoconto dello scrittore inglese Thomas de Quincey: Gli ultimi giorni di Immanuel Kant, ci
introduce a questa ulteriore esplorazione del termine. De Quincey si è basato
sulle relazioni di Vasiansky, che aveva assistito Kant in tutta la fase
terminale della sua vita. Il racconto presenta anche un
episodio singolare. Il vecchio Kant, che aveva anche enormi difficoltà a
esprimersi – Vasiansky interpretava le parole che Kant balbettava – riceve il
suo medico; questi vorrebbe che Kant si sedesse, ma il filosofo rimane in
piedi. Racconta de Quincey, con le parole di Vasiansky:
Intanto continuava a
tenersi in piedi, ma si vedeva che era sul punto di cadere a terra. Allora
avvertii il medico, e ne ero ben convinto, che Kant non si sarebbe seduto, per
quanto potesse soffrire rimanendo in piedi, finché non si fossero seduti i suoi
ospiti. Il dottore sembrava dubbioso, ma Kant, che aveva udito quel che avevo
detto, con uno sforzo prodigioso confermò la mia spiegazione del suo
comportamento e pronunciò distintamente queste parole: “Dio non voglia che io
cada così in basso da dimenticare i doveri dell’umanità”.
Certamente
nel termine “Humanität” usato da Kant
c’è il significato arcaico di “cortesia”, “gentilezza”; ma non soltanto questo.
C’è un riferimento ai doveri dell’umanità, doveri verso se stessi, ma anche
doveri verso gli altri: esistono i doveri della co-umanità.
Tutta la tradizione di riflessione
sui doveri del medico ha incluso questi doveri di co-umanità nelle
caratteristiche del buon sanitario. A partire dalla formulazione latina del
medico come “vir bonus, sanandi peritus” ( persona buona, esperta nel curare).
Ma questa “bonitas”, che determina la qualità professionale, va intesa in senso
attributivo ( un buon medico) o in senso predicativo ( un medico buono)? I
movimenti di umanizzazione della medicina accentuano la posizione predicativa:
auspicano un medico buono. Lo immaginiamo disinteressato, attento ai problemi
dei pazienti, sensibile, capace di dialogo, empatico. Talvolta queste e altre
attese sono riassunte nella richiesta che abbia una “visione olistica” del
paziente e della sua patologia, intesa come una somma di capacità e di virtù.
Dal buon medico, invece, ci si
aspetta altro. Anzitutto la competenza scientifica e un saldo dominio dell’arte
terapeutica. La scienza abbinata alla coscienza, che si è soliti invocare per
delineare il profilo del buon medico, oggi ha assunto un profilo molto preciso:
la medicina che pratica deve essere evidence
based, le linee guida hanno sostituito la libertà terapeutica, che in
passato era talvolta sinonimo di arbitrio o di preferenze immotivate. Una
cattiva medicina clinica non può essere etica; tuttavia la competenza clinica
non basta più per fare un buon medico. La novità è stata recepita dalla più
recente formulazione del Codice
deontologico dei medici italiani ( dicembre 2006). La “qualità professionale e
gestionale” (art. 6) è così descritta:
“Il medico agisce secondo
il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della persona
tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse. Il medico è tenuto a
collaborare all’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo
sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di
accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità nelle cure”.
Il
buon medico, quindi, oltre alle conoscenze scientifiche deve avere competenze
comunicative per praticare la medicina “nel modo giusto”, così come richiede la
cultura contemporanea, orientata al rispetto dell’autodeterminazione della
persona malata. E deve avere competenze gestionali, in accordo con le esigenze
dell’etica dell’organizzazione. In una parola, il buon medico non può essere
solo competente sul versante delle scienze biomediche, ma deve esserlo in
misura non minore in tutto l’arco dei saperi coltivato dalle medical humanities.
I
doveri di co-umanità riguardano anche, specularmente, quanto deve mettere in
atto chi ricorre ai servizi della medicina per essere un “buon paziente”. La Humanität del vecchio Kant, traducibile
essenzialmente in urbanità e rispetto, non basta più. La fine della “minorità
non dovuta”, che per il filosofo costituiva l’entrata nell’epoca
dell’Illuminismo e della modernità, ha modificato in profondità il modo di
esercitare la medicina. Quando il rapporto che vigeva tra sanitari e pazienti
era fondamentalmente di stampo paternalista, il buon paziente era il malato compliant: docile e remissivo, coltivava
una relazione fiduciale. Si affidava al discernimento del medico e interferiva
il meno possibile con le decisioni che questi prendeva per il bene del malato.
Non è certo proibito
comportarsi ancora secondo questo modello, se ciò corrisponde a una preferenza
personale, ma in generale non è quanto ci aspettiamo dal buon paziente dei
nostri giorni. Ai nuovi diritti corrispondono anche nuovi doveri. E nuove
responsabilità da parte del malato. Deve partecipare al processo decisionale,
prima di tutto informandosi, chiedendo. Il buon paziente non è più quello che
non fa domande: al contrario, non smette di far domande finchè non si è creato
quel quadro della situazione clinica che gli permette di decidere insieme al
medico. E deve anche accettare i limiti che il contesto dell’organizzazione
sanitaria impone alle sue richieste di servizi. Non può essere un buon paziente
chi si comporta secondo modelli di bulimia consumistica, a danno delle
legittime esigenze di altri cittadini. Tutto questo è incluso oggi nell’empowerment che si richiede per essere
un buon paziente. Questo è appunto il modello ideale di rapporto che le medical humanities vogliono promuovere.
La
formazione nelle medical humanities
Sgombriamo il terreno da
un equivoco
semantico: le medical humanities non
equivalgono alla tanto invocata “umanizzazione della medicina”. Con
quest’ultima espressione si intende per lo più fare appello ai
professionisti
sanitari perché evitino ciò che offende la sensibilità del malato di
oggi. Il
ventaglio di comportamenti ai quali si attribuisce “disumanità” è molto
ampio:
va dalla mancanza di quel rispetto che si deve a ogni persona, alla
considerazione del malato come “oggetto” di cure piuttosto che come
soggetto
con il quale relazionarsi. In ogni caso l’invito all’umanizzazione della
medicina comporta, implicitamente, un’accusa di disumanità. È chiaro
che, dal punto di vista retorico,
esprimere giudizi di valore di questo tipo significa partire con un
passo
falso: il professionista che si sente cadere addosso l’insinuazione di
essere
tanto insensibile da venire qualificato come disumano, non può che
chiudersi in un atteggiamento di
autodifesa. La denotazione del termine è troppo vaga: l’invito a
“umanizzare”
la medicina (o gli ospedali…) è talmente generico che può contenere
tutto o
nulla. La connotazione, poi, è per lo più religiosa: sono stati in
Italia
soprattutto gli ordini ospedalieri – Camilliani e Fatebenefratelli – ad
assumerlo come bandiera programmatica del cambiamento auspicato. Anche
in
ambito civile si è fatto ricorso all’umanizzazione del servizio
sanitario. Così
i decreti legislativi che all’inizio degli anni ’90 hanno disegnato il
riordino
della sanità pubblica italiana contengono un esplicito impegno a
elaborare
indicatori di qualità relativamente alla “personalizzazione e
umanizzazione dell’assistenza” (D.
Leg.vo 502/1992, art. 14).Penso tuttavia che dovremmo deciderci a
lasciar cadere un termine così ambiguo e fuorviante come
“umanizzazione”. Le medical humanities sono altro, rispetto
a un invito accorato a esercitare l’azione di cura e assistenza con il
cuore,
in un atteggiamento di fondo ispirato alla filantropia (anche
sensibilità e
amore per l’essere umano sono tutt’altro che secondari per una buona
medicina…) o al rispetto dei diritti del cittadino malato. Possiamo
considerarle un contenitore nel quale confluiscono diverse istanze. Il
fatto di
utilizzare un’etichetta enigmatica – per di più inglese! – può avere un
suo
aspetto positivo, in quanto dissipa i fraintendimenti provocati dal
termine
“umanizzazione” e costringe a chiederci di che cosa stiamo parlando.Più
che una disciplina specifica, per medical humanities intendiamo un
aggregato di saperi e di pratiche. Vi afferiscono senza esclusione tutte
le
scienze umane che hanno qualcosa da dire sull’uomo nella sua condizione
di
corporeità esposta: sia le scienze storico-interpretative (le
Humanwissenschaften o Geistwissenschaften, nella celebre distinzione
del filosofo e
storico tedesco Dilthey, che le contrapponeva alle Naturwissenschaften,
le prime rivolte alla “comprensione” dei
fenomeni, le seconde alla loro “spiegazione”), sia quelle prescrittive,
come il
diritto e l’etica.
Le medical
humanities inoltre si nutrono anche dei linguaggi dell’arte: parola
letteraria e immagini, suoni ed esperienze estetiche di varia natura. Esse
assomigliano più a un continente che a un’isola, anche se i territori
all’interno di quel continente sono differenziati e vanno esplorati con
procedure adeguate. Nelle medical
humanities sono in effetti presenti metodologie molteplici: quella del
diritto, ad esempio, non è la stessa dell’antropologia culturale, né si può
analizzare un romanzo allo stesso modo di un prodotto di Narrative based medicine.
Se
le medical
humanities costituiscono una discontinuità nel modo di intendere la
medicina,
lo sono solo rispetto a forme di riduzionismo scientista che la medicina
in
Occidente è venuta assumendo dal Positivismo in poi; nella grande
medicina del
passato e di altre tradizioni culturali, invece, le medical humanities
hanno sempre avuto diritto di cittadinanza. Il
movimento attuale che utilizza questa denominazione tiene viva la
nostalgia per
il medico “umanista”. Si tratta del modello di medico colto, che non
attinge il
suo sapere solo dalla scienza, ma anche dalle arti, e queste magari
coltiva in
proprio, da amateur. Per utilizzare
una formula enfatica coniata da Letamendi, un medico filosofo spagnolo
del XIX
secolo, “chi sa solo di medicina, non sa la medicina”. Il movimento
delle medical humanities permette inoltre di superare mediante
l’integrazione
il lungo dibattito sulle “due culture”, che ha trovato la sua
espressione più
classica nel libro di C.P. Snow Le due
culture e la rivoluzione scientifica (1960).
Chi è animato da un salutare orientamento
empirico si chiederà probabilmente a questo punto: in che modo un
professionista sanitario può essere riconosciuto come acquisito alle medical humanities? Che cosa, in
pratica, distingue ad esempio un chirurgo che si ispira ad esse? Tradurre in
atto le medical humanities equivale
alla promozione dell’intelligenza emotiva, della capacità di accogliere e di
comunicare, di avere un approccio empatico con chi si deve confrontare con le
vicende della malattia e della morte?
La mia personale risposta a queste
incalzanti domande è orientata in senso negativo. In linea generale non penso
che sia un obiettivo auspicabile che i medici e gli infermieri possano
aggiungere un M.H. al loro nome quale titolo professionale, allo stesso modo
– in ambito anglofono – di un PhD
abbinato a MD o RN… La qualità in sanità – nella sua triplice scansione:
professionale, relazionale e organizzativa – è un alto ideale, ma non esiste un
marchio di garanzia che l’assicuri a priori: essa va verificata ogni volta,
accettando che assuma, in contesti diversi e con persone diverse, una
fisionomia specifica. L’ambizione delle medical
humanities dovrebbe essere quella di proporre non una medicina con un
particolare marchio, ma semplicemente la buona medicina.
Infine una domanda, ancor più concreta: che
fisionomia potrebbe avere un intervento formativo ispirato alle medical humanities? Posso citare, a mo’
di esempio, un corso, organizzato di recente dall’Istituto Giano per le medical humanities (Roma), rivolto a
medici e infermieri, sulle direttive anticipate per le decisioni di fine vita.
Le situazioni concrete evocate dai professionisti hanno richiesto
approfondimenti di natura psicologica (come ricostruire l’attendibilità delle
preferenze espresse dal paziente?); sociale (ruolo dei familiari
nell’informazione e nelle decisioni); antropologico-culturale (concezioni
diverse del ruolo della famiglia); etica (approfondimento della nozione di
autonomia); giuridica e medico-legale (valore vincolante o soltanto indicativo
delle volontà precedentemente espresse).
Esplorando queste dimensioni, i
professionisti venivano confrontati con problemi semantici (non tutti ad
esempio davano lo stesso significato a parole come “verità”, “speranza”,
“dignità”…). L’approccio narrativo è stato implementato nel resoconto di
“storie che hanno fatto storia” (Mary Ann Quinlan, Nancy Cruzan, Terry
Schiavo…) e nella raccolta dei casi esemplari vissuti dai partecipanti al
corso.
Come conclusione, sono stati proposti dei
percorsi ideali per raccogliere preventivamente le preferenze dei pazienti e
per comunicarle a tutti i professionisti che partecipano al processo
terapeutico, nell’identico progetto di cura. Spezzoni della fiction televisiva E.R., nei quali vengono drammatizzate
situazioni di direttive anticipate, hanno ulteriormente alimentato l’interesse
dei partecipanti al corso al tema delle volontà previe. Così intese, le medical humanities non servono solo ad
“abbellire” l’anima del medico, ma ad ampliare il suo orizzonte perché eserciti
la cura con tutte le esigenze che questa comporta. Esse diventano parte
integrante dell’atto medico.
Autore: Redazione FNOMCeO